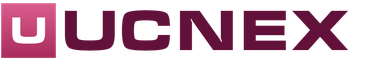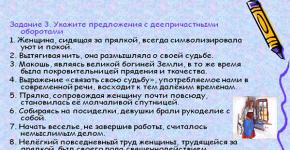Analisi dell'opera "Faust" (Goethe). tragedia filosofica e
"Faust" è un'opera che ha dichiarato la sua grandezza dopo la morte dell'autore e da allora non si è placata. La frase "Goethe - Faust" è così nota che anche una persona che non ama la letteratura ne ha sentito parlare, forse senza nemmeno sospettare chi ha scritto chi: o il Faust di Goethe o il Faust di Goethe. Tuttavia, il dramma filosofico non è solo l'eredità inestimabile dello scrittore, ma anche uno dei fenomeni più luminosi dell'Illuminismo.
"Faust" non solo regala al lettore una trama ammaliante, misticismo e mistero, ma solleva anche le questioni filosofiche più importanti. Goethe ha scritto quest'opera per sessant'anni della sua vita e l'opera è stata pubblicata dopo la morte dello scrittore. La storia della creazione dell'opera è interessante non solo per il lungo periodo della sua stesura. Già il nome della tragedia allude in modo opaco al medico Johann Faust, vissuto nel XVI secolo, che, in virtù dei suoi meriti, acquistò invidiosi. Al dottore venivano attribuiti poteri soprannaturali, presumibilmente poteva persino resuscitare persone dai morti. L'autore cambia la trama, integra la commedia con personaggi ed eventi e, come su un tappeto rosso, entra solennemente nella storia dell'arte mondiale.
L'essenza del lavoro
Il dramma si apre con una dedica, seguita da due prologhi e due parti. Vendere la tua anima al diavolo è una storia per sempre, inoltre, anche un lettore curioso sta aspettando un viaggio nel tempo.
Nel prologo teatrale inizia una discussione tra il regista, l'attore e il poeta, e ognuno di loro, infatti, ha la sua verità. Il regista sta cercando di spiegare al creatore che non ha senso creare una grande opera, poiché la maggior parte degli spettatori non è in grado di apprezzarla, a cui il poeta è ostinatamente e indignato non è d'accordo - crede che per persona creativa Innanzitutto non è importante il gusto della folla, ma l'idea stessa di creatività.
Voltando pagina, vediamo che Goethe ci ha mandato in paradiso, dove si sta preparando una nuova disputa, solo che questa volta tra il diavolo Mefistofele e Dio. Secondo il rappresentante delle tenebre, una persona non è degna di alcuna lode, e Dio ti permette di mettere alla prova la forza della tua amata creazione nella persona dell'industrioso Faust per dimostrare il contrario al diavolo.
Le due parti successive sono un tentativo di Mefistofele di vincere la discussione, vale a dire, le tentazioni diaboliche entreranno in gioco una dopo l'altra: alcol e divertimento, giovinezza e amore, ricchezza e potere. Qualsiasi desiderio senza ostacoli, finché Faust non trova ciò che è degno di vita e felicità ed è equivalente all'anima che il diavolo di solito prende per i suoi servizi.
Genere
Lo stesso Goethe ha definito la sua opera una tragedia, e i critici letterari l'hanno definita un poema drammatico, su cui è anche difficile discutere, perché la profondità delle immagini e il potere del lirismo di Faust sono di un livello insolitamente alto. Anche la natura di genere del libro tende allo spettacolo, sebbene sul palco possano essere messi in scena solo singoli episodi. Il dramma ha anche un inizio epico, motivi lirici e tragici, quindi è difficile attribuirlo a un genere specifico, ma non sarà sbagliato affermare che la grande opera di Goethe è una tragedia filosofica, una poesia e un'opera teatrale tutto insieme.
Personaggi principali e loro caratteristiche
- Faust è il protagonista della tragedia di Goethe, uno scienziato e medico eccezionale che conosceva molti dei misteri della scienza, ma era ancora deluso dalla vita. Non è soddisfatto delle informazioni frammentarie e incomplete che possiede, e gli sembra che nulla lo aiuterà a giungere alla conoscenza del significato più alto dell'essere. Il personaggio disperato ha persino contemplato il suicidio. Stringe un accordo con il messaggero delle forze oscure per trovare la felicità, qualcosa per cui vale davvero la pena vivere. Prima di tutto, è spinto dalla sete di conoscenza e libertà di spirito, quindi diventa un compito difficile per il diavolo.
- "Una particella di potere che desiderava eternamente il male, facendo solo il bene"- un'immagine piuttosto controversa del tratto di Mefistofele. Il fulcro delle forze del male, il messaggero dell'inferno, il genio della tentazione e l'antipode di Faust. Il personaggio crede che "tutto ciò che esiste è degno di morte", perché sa manipolare la migliore creazione divina attraverso le sue numerose vulnerabilità, e tutto sembra indicare quanto il lettore debba trattare negativamente il diavolo, ma dannazione! L'eroe suscita simpatia anche da parte di Dio, per non parlare del pubblico dei lettori. Goethe crea non solo Satana, ma un imbroglione spiritoso, caustico, perspicace e cinico, dal quale è così difficile distogliere lo sguardo.
- Da attori Margarita (Gretchen) può anche essere individuata separatamente. Un giovane, modesto, cittadino comune che crede in Dio, l'amato di Faust. terrestre ragazza normale che ha pagato con la propria vita la salvezza della sua anima. Personaggio principale si innamora di Margarita, ma lei non è il senso della sua vita.
- Il tema più importante dell'opera è l'eterno confronto tra il bene e il male, dove il lato del male, Mefistofele, sta cercando di sedurre il buono e disperato Faust.
- Dopo la dedica, il tema della creatività si annida nel prologo teatrale. La posizione di ciascuno dei contendenti può essere compresa, perché il regista pensa al gusto del pubblico che paga, l'attore - al ruolo più redditizio per accontentare la folla, e il poeta - alla creatività in generale. Non è difficile indovinare come Goethe intenda l'arte e da che parte stia.
- Faust è un'opera così poliedrica che qui troviamo persino il tema dell'egoismo, che non colpisce, ma una volta scoperto spiega perché il personaggio non era soddisfatto della conoscenza. L'eroe si è illuminato solo per se stesso e non ha aiutato le persone, quindi le sue informazioni accumulate negli anni erano inutili. Da ciò segue il tema della relatività di ogni conoscenza - che sono improduttive senza applicazione, risolve la questione del perché la conoscenza delle scienze non abbia portato Faust al senso della vita.
- Superando facilmente la tentazione del vino e del divertimento, Faust non si rende nemmeno conto che la prossima prova sarà molto più difficile, perché dovrà concedersi un sentimento soprannaturale. Incontrando la giovane Marguerite sulle pagine dell'opera e vedendo la folle passione di Faust per lei, guardiamo al tema dell'amore. La ragazza attrae la protagonista con la sua purezza e l'impeccabile senso della verità, inoltre, indovina la natura di Mefistofele. L'amore dei personaggi comporta sfortuna, e nella prigione Gretchen si pente dei suoi peccati. Il prossimo incontro di innamorati è previsto solo in paradiso, ma tra le braccia di Marguerite Faust non ha chiesto di aspettare un attimo, altrimenti l'opera sarebbe finita senza la seconda parte.
- Guardando da vicino l'amata di Faust, notiamo che la giovane Gretchen suscita simpatia da parte dei lettori, ma è colpevole della morte di sua madre, che non si è svegliata dopo un sonnifero. Inoltre, per colpa di Margarita, muoiono suo fratello Valentine e un figlio illegittimo di Faust, per il quale la ragazza finisce in prigione. Soffre per i peccati che ha commesso. Faust la invita a scappare, ma il prigioniero gli chiede di andarsene, arrendendosi completamente al suo tormento e al suo rimorso. Pertanto, nella tragedia viene sollevato un altro tema: il tema scelta morale. Gretchen ha scelto la morte e il giudizio di Dio piuttosto che scappare con il diavolo, e così facendo ha salvato la sua anima.
- La grande eredità di Goethe è anche densa di momenti di polemica filosofica. Nella seconda parte, guarderemo di nuovo nell'ufficio di Faust, dove il diligente Wagner sta lavorando a un esperimento, creando artificialmente una persona. L'immagine stessa dell'Homunculus è unica e nasconde un indizio nella sua vita e nelle sue ricerche. Desidera una vera esistenza nel mondo reale, sebbene sappia qualcosa che Faust non può ancora realizzare. L'intenzione di Goethe di aggiungere all'opera un personaggio così ambiguo come l'Homunculus si rivela nella presentazione dell'entelechia, lo spirito, che entra nella vita prima di ogni esperienza.
- Il problema di trovare il senso della vita è rilevante anche nell'opera di Goethe. È dall'apparente assenza di verità che Faust pensa al suicidio, perché le sue opere e le sue conquiste non gli hanno dato soddisfazione. Tuttavia, passando con Mefistofele attraverso tutto ciò che può diventare l'obiettivo della vita di una persona, l'eroe scopre comunque la verità. E poiché l'opera si riferisce a, la visione del mondo che lo circonda da parte del personaggio principale coincide con la visione del mondo di quest'epoca.
- Se guardi da vicino il personaggio principale, noterai che all'inizio la tragedia non lo fa uscire dal suo ufficio, e lui stesso non cerca davvero di uscirne. Nascosto in questo importante dettaglio c'è il problema della codardia. Studiando scienze, Faust, come se avesse paura della vita stessa, si nascose dietro i libri. Pertanto, l'apparizione di Mefistofele è importante non solo per la disputa tra Dio e Satana, ma anche per lo stesso soggetto del test. Il diavolo porta fuori un dottore di talento, lo immerge nel mondo reale, pieno di misteri e avventure, così il personaggio smette di nascondersi tra le pagine dei libri di testo e vive di nuovo, per davvero.
- Il lavoro presenta anche i lettori immagine negativa persone. Mefistofele, nel Prologo in paradiso, dice che la creazione di Dio non apprezza la ragione e si comporta come il bestiame, quindi è disgustato dalle persone. Il Signore cita Faust come controargomentazione, ma il lettore incontrerà comunque il problema dell'ignoranza della folla nel pub dove si riuniscono gli studenti. Mefistofele spera che il personaggio soccomba al divertimento, ma lui, al contrario, vuole andarsene il prima possibile.
- La pièce porta alla luce personaggi piuttosto controversi, e anche Valentine, il fratello di Margaret, ne è un ottimo esempio. Si alza per l'onore di sua sorella quando litiga con i suoi "fidanzati", morendo presto per la spada di Faust. L'opera svela il problema dell'onore e del disonore proprio sull'esempio di Valentino e di sua sorella. La degna azione del fratello esige rispetto, ma qui è piuttosto duplice: dopotutto, morendo, maledice Gretchen, tradendola così alla disgrazia universale.
Temi
Un'opera contenente un accordo tra una persona laboriosa e il diavolo, in altre parole, un patto con il diavolo, offre al lettore non solo una trama emozionante e avventurosa, ma anche argomenti di riflessione rilevanti. Mefistofele sta mettendo alla prova il protagonista, dandogli una vita completamente diversa, e ora il "topo di biblioteca" Faust sta aspettando divertimento, amore e ricchezza. In cambio della felicità terrena, dà a Mefistofele la sua anima, che, dopo la morte, deve andare all'inferno.
I problemi
Quindi, Faust ha una seconda possibilità di trascorrere la sua vita, non più seduto nel suo ufficio. È impensabile, ma qualsiasi desiderio può essere esaudito in un istante, l'eroe è circondato da tali tentazioni del diavolo, a cui è abbastanza difficile resistere per una persona comune. È possibile rimanere te stesso quando tutto è soggetto alla tua volontà - l'intrigo principale di questa situazione. La problematica dell'opera sta proprio nella risposta alla domanda, è davvero possibile stare su posizioni di virtù, quando tutto ciò che desideri solo diventa realtà? Goethe ci dà l'esempio di Faust, perché il personaggio non permette a Mefistofele di padroneggiare completamente la sua mente, ma è ancora alla ricerca del senso della vita, qualcosa per cui un momento può davvero ritardare. Aspirando alla verità, un buon dottore non solo non si trasforma in parte di un demone malvagio, il suo tentatore, ma non perde nemmeno le sue qualità più positive.
Il significato dell'opera
Dopo lunghe avventure congiunte con Mefistofele, Faust trova ancora il senso dell'esistenza, immaginando un paese prospero e un popolo libero. Non appena l'eroe capisce che la verità sta nel lavoro costante e nella capacità di vivere per il bene degli altri, pronuncia le care parole "Immediato! Oh, quanto sei bella, aspetta un po'" e muore . Dopo la morte di Faust, gli angeli salvarono la sua anima dalle forze del male, premiando il suo insaziabile desiderio di illuminazione e resistenza alle tentazioni del demone per raggiungere il suo obiettivo. L'idea dell'opera è nascosta non solo nella direzione dell'anima del protagonista verso il paradiso dopo un accordo con Mefistofele, ma anche nell'osservazione di Faust: "Solo lui è degno di vita e libertà, che ogni giorno va a combattere per loro." Goethe sottolinea la sua idea dal fatto che grazie al superamento degli ostacoli a beneficio del popolo e all'autosviluppo di Faust, il messaggero dell'inferno perde la discussione.
Cosa insegna?
Goethe non solo riflette gli ideali dell'era dell'Illuminismo nella sua opera, ma ci ispira anche a pensare all'alto destino dell'uomo. Faust dà al pubblico un'utile lezione: la costante ricerca della verità, la conoscenza delle scienze e il desiderio di aiutare le persone a salvare l'anima dall'inferno anche dopo un patto con il diavolo. Nel mondo reale, non vi è alcuna garanzia che Mefistofele ci dia un sacco di divertimento prima che ci rendiamo conto del grande significato dell'essere, quindi il lettore attento dovrebbe stringere mentalmente la mano di Faust, lodandolo per la sua resistenza e ringraziandolo per un tale suggerimento di qualità.
Interessante? Salvalo sulla tua bacheca!Il Settecento, che si concluse con la Rivoluzione francese, si sviluppò all'insegna del dubbio, della distruzione, della negazione e della fede appassionata nella vittoria della ragione sulla superstizione e sul pregiudizio, della civiltà sulla barbarie, dell'umanesimo sulla tirannia e sull'ingiustizia. Pertanto, gli storici lo chiamano l'Età dell'Illuminismo. L'ideologia dell'Illuminismo - ha trionfato in un'epoca in cui il vecchio modo medievale la vita e stava prendendo forma un nuovo ordine borghese, progressista per quel tempo. Le figure illuministe difesero ardentemente le idee di sviluppo culturale, autogoverno, libertà, difesero gli interessi delle masse, bollarono il giogo del feudalesimo, l'inerzia e il conservatorismo della chiesa.
L'era turbolenta ha dato alla luce i suoi titani: Voltaire, Diderot, Rousseau in Francia, Lomonosov in Russia, Schiller e Goethe in Germania. E i loro eroi - alla fine del secolo, Danton, Marat, Robespierre salirono sugli spalti della Convenzione rivoluzionaria di Parigi.
I gusti artistici dell'epoca erano diversi. Il barocco artistico dominava ancora l'architettura, i versi alessandrini delle tragedie di Racine e Corneille risuonavano dal palcoscenico teatrale. Ma le opere, i cui eroi erano persone del "terzo stato", stavano diventando sempre più popolari. A metà del secolo sorse un genere romanticismo sentimentale nelle lettere - i lettori seguivano con ansia la corrispondenza degli innamorati, sperimentandone i dolori e le disavventure. E a Strasburgo apparve un gruppo di giovani poeti e drammaturghi, che entrò in letteratura con il nome di "Storm and Drang". Gli eroi delle loro opere erano coraggiosi solitari, sfidando il mondo della violenza e dell'ingiustizia.
L'opera di Goethe fu una sorta di risultato dell'Età dell'Illuminismo, il risultato delle sue ricerche e lotte. E la tragedia "Faust", che il poeta ha creato per più di trent'anni, rifletteva il movimento non solo di idee scientifiche e filosofiche, ma anche tendenze letterarie. Sebbene il tempo dell'azione in "Faust" non sia definito, la sua portata è infinitamente estesa, l'intero complesso di idee è chiaramente correlato all'era di Goethe. Dopotutto, la prima parte fu scritta nel 1797-1800 sotto l'influenza delle idee e dei risultati della Grande Rivoluzione Francese, e le ultime scene furono scritte nel 1831, quando l'Europa conobbe l'ascesa e la caduta di Napoleone, la Restaurazione.
La tragedia di Goethe si basa sulla leggenda popolare di Faust, nata nel XVI secolo. Il suo eroe è un ribelle, che cerca di penetrare nei segreti della natura, opponendosi all'idea della chiesa di servile obbedienza e umiltà. In una forma semifantastica, l'immagine di Faust incarnava le forze del progresso che non potevano essere strangolate tra la gente, così come era impossibile fermare il corso della storia. Questo ricercatore della verità, che non si accontentava della realtà tedesca, era vicino a Goethe.
Gli illuministi, compreso Goethe, non rifiutarono l'idea di Dio, misero solo in discussione le dottrine della chiesa. E in "Faust" Dio appare come la mente più alta, al di sopra del mondo, al di sopra del bene e del male. Faust nell'interpretazione di Goethe è, prima di tutto, uno scienziato che mette in discussione tutto, dalla struttura del mondo alle norme morali e alle regole di comportamento. Mefistofele per lui è uno strumento di conoscenza. I mezzi della ricerca scientifica ai tempi di Goethe erano così imperfetti che molti scienziati avrebbero accettato di vendere le loro anime al diavolo per capire come funzionano il sole e i pianeti o l'occhio umano, perché esistono le epidemie di peste e cosa c'era sulla Terra prima della comparsa dell'uomo.
La ribellione di Faust, il suo tormento, il pentimento e l'intuizione, che consiste nel fatto che solo il lavoro a beneficio dell'umanità rende una persona invulnerabile alla noia e allo sconforto: tutto questo è un'incarnazione artistica delle idee dell'Illuminismo, uno dei cui geni era Goethe.
Saggio sulla letteratura sull'argomento: La tragedia filosofica di I. V. Goethe "Faust" è un'espressione delle idee educative avanzate dell'epoca
Altri scritti:
- Solo lui è degno della vita e della libertà, Chi va a combattere per loro ogni giorno. I. Goethe Goethe ha creato il suo "Faust" per tutta la vita. Sebbene Goethe non abbia scritto Faust per il teatro, è sia una tragedia che un poema filosofico. Nel Leggi di più ......
- La profondità filosofica della grande opera di Goethe, come sappiamo, è stata apprezzata da pensatori eccezionali dell'era Goethe come Schelling e Hegel. Ma si sono limitati a brevi giudizi di carattere generale. Nel frattempo, ampie cerchie di lettori sentivano che Faust aveva bisogno di chiarimenti sia in generale che Leggi di più ......
- Goethe è uno dei più grandi illuminanti. Un sottile poeta lirico, drammaturgo, romanziere, pensatore, scienziato e statista che ha servito come ministro: la natura ha generosamente dotato Johann Wolfgang Goethe. Entrò nella letteratura come precursore del romanticismo: amava le opere del folklore tedesco (conferma di questo Leggi di più ......
- Goethe ha viaggiato molto nella sua vita. Ha visitato la Svizzera tre volte: questo "paradiso in terra" ai tempi di Goethe è stato più volte cantato. Goethe ha anche viaggiato nelle città della Germania, dove ha incontrato un fenomeno straordinario: spettacoli di marionette, in cui il principale Leggi di più ......
- Goethe ha lavorato a Faust per più di sessant'anni. L'immagine del grande ricercatore della verità lo eccitò fin dalla giovinezza e lo accompagnò fino alla fine della sua vita. L'opera di Goethe è scritta sotto forma di tragedia. È vero, va ben oltre i limiti delle possibilità che ha il palcoscenico. Questo Leggi di più ......
- Le idee dell'Illuminismo hanno avuto un impatto significativo sullo sviluppo del pensiero sociale. Per tutti caratteristiche nazionali L'Illuminismo aveva diverse idee e principi generali. Esiste un unico ordine della natura, sulla cui conoscenza si basano non solo il successo delle scienze e il benessere della società, ma anche la perfezione morale e religiosa; corretto Leggi di più ......
- È stato scritto circa 10 anni prima che Goethe iniziasse a lavorare su Faust negli anni '90. È stato scritto perché Goethe ha vissuto un dramma d'amore ed è rimasto scioccato. Inoltre, è emersa una storia quando un conoscente di Goethe, che è entrato in un raccoglitore d'amore, si è suicidato. Per saperne di più ......
- ... Cosa significa sapere? Ecco dove sta tutto il problema! Chi chiamerà il bambino con il nome giusto? Dove sono quei pochi che conoscevano la loro età, non hanno nascosto i loro sentimenti o pensieri, con folle coraggio sono andati verso la folla? Furono crocifissi, picchiati, bruciati… Goethe Leggi di più ......
Nel cambiamento storico delle epoche culturali, l'illuminismo presta attenzione all'intensa concentrazione di idee in uno spazio temporale limitato. Il nuovo lettore in questa era critica ha chiesto un nuovo realtà artistica, gli scrittori hanno utilizzato intensamente nuovi modi di mostrare la realtà. La tragedia di I. Goethe "Faust" può essere giustamente considerata un'opera così nuova.
Lo scrittore ha lavorato a questo lavoro quasi tutta la sua vita. La prima idea gli venne quando aveva poco più di vent'anni e completò la composizione del Faust pochi anni prima di morire.
Considerando che Goethe ha vissuto nel mondo per quasi ottantadue anni, è facile calcolare che siano trascorsi circa sessant'anni dall'inizio dei lavori sul Faust fino al suo completamento.
L'opera di Goethe non si presta a una chiara definizione alla luce di categorie letterarie generalmente accettate, come, ad esempio, classicismo, romanticismo o realismo. Faust è un'opera poetica di uno stile speciale, estremamente raro. Il ricercatore della creatività di Goethe A. Anixt definisce caratteristica del genere"Faust" come una sorta di universalismo artistico, poiché include elementi di natura artistica diversi.
Prima di tutto, quando si legge Faust, il sottile intreccio di elementi di finzione, finzione reale, a volte anche naturalistica, ed evidente, attira l'attenzione. Quindi, la baldoria degli studenti nella cantina di Auerbach appartiene alle scene reali di tutti i giorni, l'incontro dell'eroe con Margarita appartiene alle scene liriche, Gretchen nella prigione è tragica. Gli episodi del contratto di Faust con il diavolo, la cucina della strega, la notte di Valpurga sono del tutto irrealistici e sono generati dalla fantasia del poeta. Tuttavia, la fantasia di Goethe, in ultima analisi, è sempre connessa con la realtà. Allo stesso tempo, le immagini reali in Faust sono intrise di un significato che va oltre i limiti di un caso particolare e hanno un carattere simbolico generalizzato.
Inoltre, il lavoro di Goethe riflette idee illuministiche avanzate. In primo luogo, l'Illuminismo si sviluppò come movimento per lo studio della natura, la comprensione delle sue leggi e l'uso di scoperte scientifiche a beneficio dell'umanità. Queste idee erano di carattere paneuropeo, ma furono sviluppate soprattutto in Germania. Inseguimento Le migliori persone a una nuova vita si manifestava non nella lotta politica e nemmeno nell'attività pratica, ma nell'attività mentale. La più alta incarnazione del pensiero filosofico avanzato e della creatività artistica di quel tempo era il Faust di Goethe.
È interessante notare che lo stesso scrittore era contrario ai tentativi di trovare risposte concrete a difficili domande della vita nel suo lavoro. Disse che lui stesso non conosceva l'idea del suo lavoro e non poteva esprimerlo: "In effetti, sarebbe una buona cosa se provassi a mettere insieme una vita così ricca, colorata ed estremamente diversificata che metto nel mio Faust su un filo sottile di un'unica idea per l'intero lavoro". Tuttavia, le parole del poeta non dovrebbero essere prese alla lettera, nel senso che nega la presenza di un'idea nella sua opera in quanto tale. C'è un centro organizzativo nel suo lavoro: questa è la personalità del protagonista, Faust, che è una figura simbolica che incarna tutta l'umanità.
Faust è senza dubbio una persona viva con passioni e sentimenti inerenti ad altre persone. È capace di sbagliare, soffrire, sbagliare. Nella sua natura, come nella natura di qualsiasi altra persona, erano incarnati due principi: il bene e il male. Nel frattempo, Faust è ben consapevole della sua imperfezione. La sua caratteristica più bella è l'eterna insoddisfazione di se stessi e del mondo che li circonda, il desiderio di migliorare e rendere il mondo un luogo più perfetto in cui le persone possono vivere e svilupparsi. Il percorso di vita di Faust è il percorso della ricerca incessante.
Il padre di Faust era un medico e gli ha instillato l'amore per la scienza. Ma la guarigione del padre si è rivelata impotente contro le malattie che colpivano le persone. Durante un'epidemia di peste, Faust si rivolge al cielo con una preghiera, ma neanche da lì arriva l'aiuto, da cui Faust conclude che gli appelli a Dio sono privi di significato. Deluso dalla religione, decide di dedicarsi interamente alla scienza. Lunghi anni Faust si dedica allo studio delle complessità scientifiche, ma gradualmente giunge alla conclusione che tutti i suoi tentativi sono infruttuosi:
Le pergamene non placano la sete.
La chiave della saggezza non è nelle pagine dei libri.
Chi è strappato ai segreti della vita da ogni pensiero,
Nella sua anima trova la loro sorgente.
La disperazione di Faust arriva a tal punto che decide di suicidarsi, ma nel momento decisivo si sentono campane che suonano e canti corali e un bicchiere di veleno cade dalle mani di un perdente suicida. Ma non è il ricordo di Dio e non la coscienza della peccaminosità del suicidio che induce Faust ad abbandonare l'intenzione di porre fine alla sua vita. Ricorda come, durante l'infanzia, il misterioso ronzio delle campane ha dato vita a qualcosa di puro e luminoso nel cuore. Nella preghiera di perfetti sconosciuti e estranei Faust sente la richiesta di aiuto dell'umanità: proprio come si rivolgeva a Dio con una preghiera in tempi difficili, così ora le persone che pregano che non sanno come trovare una via d'uscita dalle difficoltà si rivolgono alla religione, cercando in essa sostegno.
Faust decide di tornare alla conoscenza scientifica della vita, ma ora non è interessato alla conoscenza dei libri, poiché sono morti e lontani dalla vita. La conoscenza che l'eroe sta cercando è concentrata nel fitto degli eventi della vita.
In questo momento critico, Mefistofele, che incarna le forze del male, si incontra sulla via di Faust, è sicuro che il genere umano sia ingrato e che nella vita una persona sia guidata solo dalle proprie passioni. L'immagine di Goethe del diavolo che seduce una persona è lontana dalle nozioni popolari. Mefistofele è scaltro e "diabolicamente" intelligente. Lui stesso dice di se stesso che "fa del bene, desiderando il male a tutto". Come ricordiamo, una tale visione delle forze del male era insita nello scrittore russo M. Bulgakov, che prese le parole di Goethe come epigrafe del romanzo "Il maestro e Margherita": "Faccio parte di quella forza che vuole sempre il male, ma fa sempre il bene". Mefistofele gioca un ruolo molto importante nella tragedia. Spinge costantemente Faust al male, ma, senza aspettarselo lui stesso, si risveglia in lui i lati migliori natura.
Faust acquisisce la più alta saggezza solo alla fine della vita. Capisce che la vera felicità di ogni persona sta nella ricerca, nella lotta e nel lavoro. L'anima di Faust è oscurata dalla "grazia divina". Il concetto di "grazia divina" in Goethe viene ripensato secondo le idee avanzate dell'epoca. Anche Aristotele nella "Poetica" scriveva: "Il carattere è ciò in cui si trova la direzione della volontà"; "questo carattere sarà nobile se troverà una nobile direzione della volontà." Faust va ai suoi successi, subendo perdite, tormentato, sofferente, tormentato da dubbi e costante insoddisfazione. Ma mostra una nobile forza di volontà, le sue aspirazioni sono pure e disinteressate. L'immagine di Faust incarnava l'ideale umano dal punto di vista degli illuministi, che credevano che il significato della vita umana fosse la lotta per la verità e la giustizia eterne.
Risultati dell'Illuminismo: "Faust" di J. V. Goethe.
Il più grande poeta, scienziato e pensatore tedesco Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) completa l'Illuminismo europeo. In termini di versatilità dei suoi talenti, Goethe si trova accanto ai titani del Rinascimento. Già i contemporanei del giovane Goethe parlavano in coro del genio di ogni manifestazione della sua personalità, e in relazione al vecchio Goethe si stabiliva la definizione di “olimpico”.
Proveniente da una famiglia patrizia borghese di Francoforte sul Meno, Goethe ha ricevuto un'eccellente educazione umanistica a casa, ha studiato alle università di Lipsia e Strasburgo. Inizia attività letteraria ha rappresentato la formazione nella letteratura tedesca del movimento "Storm and Onslaught", a capo del quale si trovava. La sua fama si diffuse oltre la Germania con la pubblicazione del romanzo I dolori del giovane Werther (1774). Al periodo dell'assalto appartengono anche i primi schizzi della tragedia "Faust".
Nel 1775 Goethe si trasferì a Weimar su invito del giovane duca di Sassonia-Weimar, che lo ammirava, e si dedicò agli affari di questo piccolo stato, volendo realizzare la sua sete creativa nell'attività pratica a beneficio della società. La sua decennale attività amministrativa, anche da primo ministro, non lasciava spazio alla creatività letteraria e gli procurava delusioni. Lo scrittore H. Wieland, che conosceva più da vicino l'inerzia della realtà tedesca, disse fin dall'inizio della carriera ministeriale di Goethe: "Goethe non sarà in grado di fare nemmeno un centesimo di quello che sarebbe felice di fare". Nel 1786 Goethe subì una grave crisi mentale che lo costrinse a partire per l'Italia per due anni, dove, nelle sue parole, “resuscitò”.
In Italia inizia l'aggiunta del suo metodo maturo, chiamato "classicismo di Weimar"; in Italia torna alla creatività letteraria, dalla sua penna escono i drammi Ifigenia in Tauride, Egmont, Torquato Tasso. Al suo ritorno dall'Italia a Weimar, Goethe conserva solo la carica di Ministro della Cultura e Direttore del Teatro di Weimar. Lui, ovviamente, rimane un amico personale del duca e fornisce consulenza sulle questioni politiche più importanti. Negli anni Novanta del Settecento iniziò l'amicizia di Goethe con Friedrich Schiller, un'amicizia unica nella storia della cultura e collaborazione creativa tra due altrettanto grandi poeti. Insieme hanno sviluppato i principi del classicismo di Weimar e si sono incoraggiati a vicenda a creare nuove opere. Negli anni 1790 Goethe scrisse "Reinecke Lis", "Roman Elegies", il romanzo "Gli anni dell'insegnamento di Wilhelm Meister", l'idillio borghese in esametri "Hermann e Dorothea", ballate. Schiller ha insistito affinché Goethe continuasse a lavorare su Faust, ma Faust. La prima parte della tragedia” fu completata dopo la morte di Schiller e pubblicata nel 1806. Goethe non intendeva più tornare su questo piano, ma lo scrittore I. P. Eckerman, che si stabilì a casa sua come segretario, autore di Conversazioni con Goethe, esortò Goethe a completare la tragedia. La seconda parte del Faust si sviluppò soprattutto negli anni Venti, e fu pubblicata, per volere di Goethe, dopo la sua morte. Così, il lavoro su "Faust" ha richiesto più di sessant'anni, ha coperto l'intero vita creativa Goethe e ha assorbito tutte le epoche del suo sviluppo.
Proprio come nelle storie filosofiche di Voltaire, in "Faust" l'idea filosofica è la parte principale, solo rispetto a Voltaire, era incarnata nelle immagini vive e sincere della prima parte della tragedia. Il genere di "Faust" è una tragedia filosofica, ei problemi filosofici generali che Goethe affronta qui acquistano una speciale colorazione illuministica. La trama di Faust è stata usata molte volte nella moderna letteratura tedesca da Goethe, e lui stesso lo ha incontrato per la prima volta da bambino di cinque anni a uno spettacolo di teatro di marionette popolare che interpretava un'antica leggenda tedesca. Tuttavia, questa leggenda ha radici storiche. Il dottor Johann-Georg Faust era un guaritore itinerante, stregone, indovino, astrologo e alchimista. Studiosi contemporanei come Paracelso ne parlavano come di un impostore ciarlatano; dal punto di vista dei suoi studenti (Faust un tempo aveva una cattedra all'università), era un impavido cercatore di conoscenza e percorsi proibiti. I seguaci di Martin Lutero (1583-1546) lo vedevano come un uomo malvagio che, con l'aiuto del diavolo, operava miracoli immaginari e pericolosi. Dopo la sua morte improvvisa e misteriosa nel 1540, la vita di Faust si riempie di leggende.
Il libraio Johann Spies raccolse per primo la tradizione orale in un libro popolare su Faust (1587, Francoforte sul Meno). Era un libro edificante, "un fantastico esempio della tentazione del diavolo di distruggere il corpo e l'anima". Spies ha anche un accordo con il diavolo per un periodo di 24 anni, e il diavolo stesso sotto forma di cane che si trasforma in un servitore di Faust, il matrimonio con Elena (lo stesso diavolo), il famoso Wagner, la terribile morte di Faust.
La trama è stata rapidamente ripresa dalla letteratura dell'autore. Il brillante contemporaneo di Shakespeare, l'inglese K. Marlo (1564–1593), diede il suo primo adattamento teatrale in “ storia tragica vita e morte del dottor Faust” (la prima volta nel 1594). La popolarità della storia di Faust in Inghilterra e in Germania nei secoli XVII-XVIII è evidenziata dall'elaborazione del dramma in pantomima e spettacoli teatri di marionette. Molti scrittori tedeschi la seconda metà del XVIII secolo utilizzò questo terreno. Il dramma di G. E. Lessing "Faust" (1775) rimase incompiuto, J. Lenz nel drammatico passaggio "Faust" (1777) raffigurava Faust all'inferno, F. Klinger scrisse il romanzo "La vita, le azioni e la morte di Faust" (1791). Goethe ha portato la leggenda a un livello completamente nuovo.
Per sessant'anni di lavoro su Faust, Goethe ha creato un'opera paragonabile per volume all'epopea omerica (12.111 versi di Faust contro 12.200 versi dell'Odissea). Avendo assorbito l'esperienza di una vita, l'esperienza di una brillante comprensione di tutte le epoche della storia dell'umanità, l'opera di Goethe si basa su modi di pensare e tecniche artistiche che sono lontane da quelle accettate in letteratura contemporanea, Ecco perché Il modo migliore avvicinarsi a lui è una piacevole lettura commentata. Qui delineeremo solo la trama della tragedia dal punto di vista dell'evoluzione del protagonista.
Nel Prologo in cielo, il Signore fa una scommessa con il diavolo Mefistofele sulla natura umana; Il Signore sceglie il suo “schiavo”, il dottor Faust, come oggetto dell'esperimento.
Nelle scene iniziali della tragedia, Faust è profondamente deluso dalla vita che ha dedicato alla scienza. Disperava di conoscere la verità e ora è sull'orlo del suicidio, dal quale è trattenuto dal suono delle campane pasquali. Mefistofele entra in Faust sotto forma di un barboncino nero, assume il suo vero aspetto e fa un patto con Faust: l'adempimento di uno qualsiasi dei suoi desideri in cambio della sua anima immortale. La prima tentazione - il vino nella cantina di Auerbach a Lipsia - Faust rifiuta; dopo un magico ringiovanimento nella cucina della strega, Faust si innamora della giovane cittadina Marguerite e, con l'aiuto di Mefistofele, la seduce. A causa del veleno dato da Mefistofele, la madre di Gretchen muore, Faust uccide suo fratello e fugge dalla città. Nella scena della Notte di Valpurga, al culmine del sabba delle streghe, Faust vede il fantasma di Marguerite, la sua coscienza si risveglia in lui e chiede a Mefistofele di salvare Gretchen, che è stata gettata in prigione per aver ucciso il bambino che ha partorito. Ma Margarita si rifiuta di scappare con Faust, preferendo la morte, e la prima parte della tragedia si conclude con le parole di una voce dall'alto: "Salvata!" Così, nella prima parte, che si svolge nel medioevo tedesco condizionale, Faust, che nella sua prima vita era uno scienziato eremita, acquisisce l'esperienza di vita di un privato.
Nella seconda parte l'azione viene trasferita nel vasto mondo esterno: alla corte dell'imperatore, nella misteriosa grotta delle Madri, dove Faust si tuffa nel passato, nell'era precristiana, e da dove porta Elena la Bella. Un breve matrimonio con lei si conclude con la morte del figlio Euforione, a simboleggiare l'impossibilità di una sintesi tra ideali antichi e cristiani. Dopo aver ricevuto terre costiere dall'imperatore, il vecchio Faust trova finalmente il senso della vita: nelle terre strappate al mare vede un'utopia di felicità universale, l'armonia del lavoro libero su una terra libera. Al suono delle pale, il vecchio cieco pronuncia il suo ultimo monologo: "Ora sto vivendo il momento più alto" e, secondo i termini dell'accordo, cade morto. L'ironia della scena è che Faust prende gli scagnozzi di Mefistofele come costruttori, scavando la sua tomba, e tutte le opere di Faust sull'organizzazione della regione vengono distrutte da un'alluvione. Tuttavia, Mefistofele non ottiene l'anima di Faust: l'anima di Gretchen lo difende davanti alla Madre di Dio e Faust sfugge all'inferno.
Faust è una tragedia filosofica; al centro ci sono le principali questioni dell'essere, determinano sia la trama che il sistema di immagini, e sistema artistico generalmente. Di norma, la presenza di un elemento filosofico nel contenuto opera letteraria implica un maggiore grado di convenzionalità nella sua forma d'arte, come è già stato mostrato nel racconto filosofico di Voltaire.
La fantastica trama di "Faust" porta l'eroe attraverso diversi paesi ed epoche di civiltà. Poiché Faust è il rappresentante universale dell'umanità, l'intero spazio del mondo e l'intera profondità della storia diventano l'arena della sua azione. Pertanto, l'immagine delle condizioni vita pubblicaè presente nella tragedia solo nella misura in cui si basa sulla leggenda storica. Nella prima parte ci sono ancora schizzi di genere vita popolare(la scena dei festeggiamenti a cui vanno Faust e Wagner); nella seconda parte, filosoficamente più complessa, viene proposta al lettore una rassegna generalizzata-astratta delle principali epoche della storia dell'umanità.
L'immagine centrale della tragedia - Faust - l'ultimo dei grandi " immagini eterne” individualisti nati nel passaggio dal Rinascimento al New Age. Deve essere collocato accanto a Don Chisciotte, Amleto, Don Juan, ognuno dei quali incarna un estremo dello sviluppo dello spirito umano. Faust rivela la maggior parte dei punti di somiglianza con Don Juan: entrambi si sforzano nei regni proibiti della conoscenza occulta e segreti sessuali, entrambi non si fermano davanti all'omicidio, l'irreprimibilità dei desideri mette entrambi in contatto con le forze infernali. Ma a differenza di Don Juan, la cui ricerca si trova su un piano puramente terreno, Faust incarna la ricerca della pienezza della vita. La sfera di Faust è conoscenza sconfinata. Proprio come Don Juan è completato dal suo servitore Sganarello e Don Chisciotte da Sancho Panza, Faust è completato dal suo eterno compagno, Mefistofele. Il diavolo in Goethe perde la maestà di Satana, un titano e un combattente di Dio: questo è il diavolo di tempi più democratici, ed è collegato a Faust non tanto dalla speranza di ottenere la sua anima quanto dall'affetto amichevole.
La storia di Faust consente a Goethe di adottare un approccio fresco e critico alle questioni chiave della filosofia illuminista. Ricordiamo che la critica della religione e dell'idea di Dio era il nervo dell'ideologia illuminista. In Goethe, Dio sta al di sopra dell'azione della tragedia. Il Signore del "Prologo in cielo" è un simbolo degli inizi positivi della vita, la vera umanità. A differenza della precedente tradizione cristiana, il Dio di Goethe non è severo e non combatte nemmeno il male, ma, al contrario, comunica con il diavolo e si impegna a dimostrargli l'inutilità della posizione di completa negazione del senso della vita umana. Quando Mefistofele paragona un uomo a una bestia feroce o a un insetto schizzinoso, Dio gli chiede:
Conosci Fausto? - Lui è un medico? - È il mio schiavo.
Mefistofele conosce Faust come dottore in scienze, cioè lo percepisce solo per la sua affiliazione professionale con gli scienziati, poiché il Signore Faust è il suo schiavo, cioè il portatore della scintilla divina, e, offrendo a Mefistofele una scommessa, il Signore è sicuro in anticipo del suo esito:
Quando un giardiniere pianta un albero, il Frutto è noto in anticipo al giardiniere.
Dio crede nell'uomo, ecco perché permette a Mefistofele di tentare Faust per tutta la sua vita terrena. Per Goethe, il Signore non ha bisogno di intervenire in un ulteriore esperimento, perché sa che una persona è buona per natura, e le sue ricerche terrene contribuiscono solo alla fine al suo miglioramento, esaltazione.
Faust, all'inizio dell'azione nella tragedia, aveva perso la fede non solo in Dio, ma anche nella scienza, alla quale aveva dato la vita. I primi monologhi di Faust parlano della sua profonda delusione per la vita che ha vissuto, che è stata data alla scienza. Né la scienza scolastica del Medioevo, né la magia gli danno risposte soddisfacenti sul senso della vita. Ma i monologhi di Faust sono stati creati alla fine dell'Illuminismo, e se il Faust storico poteva conoscere solo la scienza medievale, nei discorsi del Faust di Goethe c'è una critica all'ottimismo illuminista riguardo alle possibilità conoscenza scientifica e progresso tecnico, critica della tesi dell'onnipotenza della scienza e della conoscenza. Lo stesso Goethe non si fidava degli estremi del razionalismo e del razionalismo meccanicistico, in gioventù era molto interessato all'alchimia e alla magia, e con l'aiuto di segni magici, Faust all'inizio dell'opera spera di comprendere i segreti della natura terrena. L'incontro con lo Spirito della Terra rivela a Faust per la prima volta che l'uomo non è onnipotente, ma trascurabile rispetto al mondo che lo circonda. Questo è il primo passo di Faust sulla via della conoscenza. propria essenza e il suo autocontrollo: la trama della tragedia consiste nello sviluppo artistico di questo pensiero.
Goethe pubblicò Faust, a partire dal 1790, in parti, il che rese difficile per i suoi contemporanei valutare l'opera. Delle prime dichiarazioni, due attirano l'attenzione su di sé, il che ha lasciato il segno in tutti i successivi giudizi sulla tragedia. Il primo appartiene al fondatore del romanticismo F. Schlegel: “Quando l'opera sarà completata, incarnerà lo spirito della storia mondiale, diventerà un vero riflesso della vita dell'umanità, del suo passato, presente e futuro. In Faust, idealmente, è raffigurata tutta l'umanità, diventerà l'incarnazione dell'umanità.
Il creatore della filosofia romantica F. Schelling ha scritto nella sua “Filosofia dell'arte”: “... a causa della peculiare lotta che sorge oggi nella conoscenza, quest'opera ha ricevuto una colorazione scientifica, così che se qualche poesia può essere definita filosofica, allora questo vale solo per il Faust di Goethe. Una mente brillante, che unisce la profondità di un filosofo con la forza di un poeta eccezionale, ci ha dato in questa poesia una fonte di conoscenza eternamente fresca...” Interessanti interpretazioni della tragedia furono lasciate da I. S. Turgenev (articolo “Faust”, una tragedia, 1855), il filosofo americano R. W. Emerson (“Goethe come scrittore”, 1850).
Il più grande germanista russo V. M. Zhirmunsky ha sottolineato la forza, l'ottimismo, l'individualismo ribelle di Faust, ha contestato l'interpretazione del suo percorso nello spirito del pessimismo romantico: "Nel piano generale della tragedia, la delusione di Faust [delle prime scene] è solo una tappa necessaria nei suoi dubbi e nella ricerca della verità" (" storia creativa"Faust" di Goethe, 1940).
È significativo che lo stesso concetto sia formato dal nome di Faust, come dai nomi degli altri eroi letterari la stessa riga. Ci sono interi studi sul donchisciottismo, sull'amletismo, sul dongiovannismo. Il concetto di "uomo faustiano" è entrato negli studi culturali con la pubblicazione del libro di O. Spengler "The Decline of Europe" (1923). Faust per Spengler è uno dei due tipi umani eterni, insieme al tipo Apollo. Quest'ultima corrisponde alla cultura antica, e per l'anima faustiana “il pra-simbolo è puro spazio sconfinato, e il“ corpo ”è la cultura occidentale che fiorì nelle pianure settentrionali tra l'Elba e il Tajo contemporaneamente alla nascita dello stile romanico nel X secolo ... Faustiano - la dinamica di Galileo, il dogma cattolico-protestante, il destino di Lear e l'ideale della Madonna, a partire da Beatrice Dante fino alla scena finale della seconda parte del “Fau centinaio”.
IN ultimi decenni l'attenzione dei ricercatori si è concentrata sulla seconda parte del Faust, dove, secondo il professore tedesco K. O. Konradi, “l'eroe, per così dire, interpreta vari ruoli che non sono accomunati dalla personalità dell'esecutore. Questo divario tra il ruolo e l'esecutore lo trasforma in una figura puramente allegorica.
"Faust" ha avuto un enorme impatto sul tutto letteratura mondiale. La grandiosa opera di Goethe non era ancora stata completata, quando, sotto la sua impressione, apparvero "Manfred" (1817) di J. Byron, "Scene da "Faust"" (1825) di A. S. Pushkin, il dramma di H. D. Grabbe "Faust e Don Giovanni" (1828) e molte continuazioni della prima parte di "Faust". Il poeta austriaco N. Lenau creò il suo "Faust" nel 1836, G. Heine - nel 1851. Il successore di Goethe nella letteratura tedesca del XX secolo T. Mann ha creato il suo capolavoro "Doctor Faustus" nel 1949.
Faust in Russia è stato espresso nella storia Faust di I. S. Turgenev (1855), nelle conversazioni di Ivan con il diavolo nel romanzo di F. M. Dostoevskij I fratelli Karamazov (1880), nell'immagine di Woland nel romanzo di M. A. Bulgakov Il maestro e Margherita (1940). Il "Faust" di Goethe è un'opera che riassume il pensiero illuminista e va oltre la letteratura dell'Illuminismo, aprendo la strada al futuro sviluppo della letteratura nel XIX secolo.
Pagina 1
Il Faust di Goethe è un dramma profondamente nazionale. Il conflitto più spirituale del suo eroe, l'ostinato Faust, che si ribellò a vegetare nella vile realtà tedesca in nome della libertà di azione e di pensiero, è già nazionale. Tali erano le aspirazioni non solo del popolo del sedicesimo secolo ribelle; gli stessi sogni hanno dominato la coscienza dell'intera generazione di Sturm und Drang, con cui Goethe è entrato nel campo letterario. Ma proprio perché le masse popolari nella moderna Germania di Goethe non erano in grado di spezzare le catene feudali, di "rimuovere" la tragedia personale dell'uomo tedesco, insieme a tragedia comune del popolo tedesco, il poeta doveva guardare con maggiore attenzione agli affari e ai pensieri di popoli stranieri, più attivi, più avanzati. In questo senso e per questo Faust non parla solo della Germania, ma in fondo dell'intera umanità, chiamata a trasformare il mondo attraverso un lavoro congiunto, libero e razionale. Belinsky aveva ugualmente ragione quando affermava che Faust "è un riflesso completo dell'intera vita della società tedesca contemporanea", e quando affermava che questa tragedia "contiene tutte le domande morali che possono sorgere nel petto dell'uomo interiore del nostro tempo". Goethe iniziò a lavorare al Faust con l'audacia di un genio. Il tema stesso del "Faust" - un dramma sulla storia dell'umanità, sullo scopo della storia umana - gli era ancora poco chiaro, nella sua interezza; eppure lo ha intrapreso nella speranza che a metà della storia avrebbe raggiunto il suo piano. Goethe si è affidato qui alla collaborazione diretta con il "genio del secolo". Proprio come gli abitanti di un paese sabbioso e siliceo dirigono abilmente e con zelo ogni ruscello filtrato, tutta l'avara umidità del sottosuolo nei loro bacini, così Goethe per molto tempo percorso di vita con inesorabile tenacia, ha raccolto nel suo Faust ogni accenno profetico della storia, tutto il senso storico sotterraneo dell'epoca.
Totale modo creativo Goethe nel XIX secolo accompagna il lavoro sulla sua creazione principale: "Faust". La prima parte della tragedia è stata sostanzialmente completata l'anno scorso XVIII secolo, ma pubblicato integralmente nel 1808. Nel 1800 Goethe lavorò su un frammento di "Elena", che fu la base dell'Atto III della seconda parte, creato principalmente nel 1825-1826. Ma il lavoro più intenso sulla seconda parte e il suo completamento cadono nel 1827-1831. Fu pubblicato nel 1833, dopo la morte del poeta.
Il contenuto della seconda parte, come la prima, è insolitamente ricco, ma in essa si possono distinguere tre principali complessi ideologici e tematici. Il primo è legato alla rappresentazione del regime fatiscente dell'Impero feudale (atti I e IV). Qui il ruolo di Mefistofele è particolarmente significativo. Con le sue azioni, per così dire, provoca la corte imperiale, le sue figure grandi e piccole, le spinge all'auto-rivelazione. Offre la parvenza di una riforma (emissione di cartamoneta) e, intrattenendo l'imperatore, lo stordisce con una fantasmagoria di una mascherata, dietro la quale traspare chiaramente il carattere clownesco di tutta la vita di corte. L'immagine del crollo dell'Impero in Faust riflette la percezione di Goethe della Rivoluzione francese.
Secondo argomento principale la seconda parte è legata alle riflessioni del poeta sul ruolo e sul significato dell'assimilazione estetica della realtà. Goethe sposta audacemente i tempi: la Grecia omerica, l'Europa cavalleresca medievale, in cui Faust trova Elena, e il XIX secolo, incarnato condizionatamente nel figlio di Faust ed Elena - Euforione, un'immagine ispirata alla vita e al destino poetico di Byron. Questo spostamento di tempi e di paesi sottolinea l'universalità del problema dell'"educazione estetica", per usare il termine di Schiller. L'immagine di Elena simboleggia la bellezza e l'arte stessa e, allo stesso tempo, la morte di Euphorion e la scomparsa di Elena significano una sorta di "addio al passato" - il rifiuto di tutte le illusioni associate al concetto di classicismo di Weimar, come, infatti, si è già riflesso in il mondo dell'arte il suo divano. Il terzo - e principale - tema è rivelato nel quinto atto. L'impero feudale sta crollando, innumerevoli disastri segnano l'avvento di una nuova era capitalista. "Rapina, commercio e guerra", formula la moralità dei nuovi maestri della vita Mefistofele e lui stesso agisce nello spirito di questa moralità, esponendo cinicamente il lato sbagliato del progresso borghese. Faust, alla fine del suo viaggio, formula la "conclusione finale della saggezza terrena": "È degno della vita e della libertà solo colui che ogni giorno va a combattere per loro". Le parole da lui pronunciate una volta, nella scena della traduzione della Bibbia: "In principio c'era un atto", acquistano un significato socio-pratico: Faust sogna di fornire la terra strappata al mare a "molti milioni" di persone che vi lavoreranno. L'ideale astratto dell'atto, espresso nella prima parte della tragedia, la ricerca di modi di auto-miglioramento individuale sono sostituiti da nuovo programma: l'oggetto dell'atto è proclamato "milioni", che, divenuti "liberi e attivi", in una lotta instancabile contro le formidabili forze della natura, sono chiamati a creare un "paradiso in terra".
Articoli utili:
Motivi antichi nella poesia di Valery Bryusov. Valery Bryusov - il fondatore del simbolismo russo
Famoso poeta, scrittore di prosa, traduttore, editore, giornalista, personaggio pubblico di spicco Età dell'argento e i primi anni post-ottobre, Valery Yakovlevich Bryusov (1873-1924) a cavallo tra il secolo in uscita e quello in arrivo, portato via dal francese alla moda...
Le scuole pre-rivoluzionarie erano innovazioni
Di solito gli studi epici del XIX e dell'inizio del XX secolo sono divisi in una serie di scuole, vale a dire: scuole mitologiche, comparative e storiche. La scuola mitologica sorse nella prima metà del XIX secolo. in Germania sotto l'influenza del romanticismo e della delusione in e ...
Confronto tra le trame di "Shadow" di Schwartz e Andersen
La commedia "Shadow" di E.L. Schwartz ha scritto nel 1940. Il testo dell'opera è preceduto da un'epigrafe: una citazione dalla fiaba di Andersen e una citazione dalla sua autobiografia, quindi Schwartz si riferisce apertamente al narratore danese, sottolinea la vicinanza del suo pro...