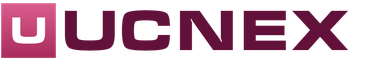Il metodo di Sherlock: come sviluppare l'osservazione, la deduzione e la flessibilità del pensiero. Lettura del fine settimana “Una mente straordinaria” di Maria Konnikova Il metodo scientifico di pensare
Sherlock Holmes, l'eroe delle opere di Arthur Conan Doyle, è noto al mondo come un brillante detective. Tuttavia, molte persone sono abbastanza capaci di allenare il proprio cervello a pensare allo stesso modo in cui pensava Holmes. Come? Sto solo riproducendo il comportamento di Holmes. Se diventi più attento e impari ad analizzare meglio le tue osservazioni, non dovrebbero sorgere problemi. Se questo non ti basta, puoi esercitarti a costruire i tuoi “palazzi mentali”.
Passi
Parte 1
Guarda e osserva- La concentrazione consentirà alla tua mente di rimanere concentrata più a lungo e le insegnerà a risolvere i problemi in modo più efficiente ed efficace.
- La messa a fuoco è forse uno degli aspetti più semplici dell’osservazione. Tutto ciò che ti viene richiesto è focalizzare tutta la tua attenzione sull'oggetto dell'osservazione, senza lasciarti distrarre da nient'altro.
-
Sii selettivo. Se osservi tutto ciò che è nel tuo campo visivo, la tua testa girerà e abbastanza rapidamente. Sì, devi imparare ad osservare, ma allo stesso tempo devi essere selettivo in ciò che osservi esattamente.
- In questo caso, per te, la qualità è più importante della quantità. È necessario osservare in modo più qualitativo e non più oggetti o fenomeni.
- Di conseguenza, devi imparare a determinare cosa è importante e cosa no. La pratica ti porterà alla perfezione e solo la pratica ti renderà perfetto.
- Individuato ciò che è importante, osserva e analizza tutto, fin nel più piccolo dettaglio.
- Se non riesci a raccogliere abbastanza dettagli da ciò che stai osservando, dovresti espandere lentamente l'area di osservazione per includere ciò che in precedenza consideravi non degno di attenzione.
-
Sii obiettivo. Purtroppo, la stessa natura umana lo contraddice: tutti abbiamo dei pregiudizi. Per imparare ad osservare è necessario superare se stessi e abbandonare tutti i pregiudizi per diventare un osservatore obiettivo.
- Il cervello spesso vede solo ciò che vuole vedere e poi lo fa passare completamente per un fatto. Ahimè, questo non è un dato di fatto, è solo una visione di un oggetto o fenomeno. Una volta che il nostro cervello ricorda un fatto, diventa difficile per lui accettare il contrario. Devi imparare a concentrarti sulla tua obiettività per non ricevere dati falsi e inaffidabili dalle tue osservazioni.
- Ricorda che l'osservazione e la deduzione sono due parti diverse del processo. Osservando, stai solo osservando. Successivamente, quando viene attivato il metodo deduttivo, si inizia ad analizzare le informazioni raccolte.
-
Non limitare le tue osservazioni a un senso. Ciò che vedi è solo una parte del mondo. Le tue osservazioni dovrebbero estendersi ad altri sensi: udito, olfatto, gusto e tatto.
- Impara a usare la vista, l'udito e l'olfatto. Facciamo affidamento più spesso su questi tre sentimenti, ma sono quelli che ci fuorviano più spesso. Solo quando potrai sentire tutto questo in modo oggettivo, impara a usare i sensi del tatto e del gusto.
-
Meditare. Quindici minuti di meditazione quotidiana sono un modo pratico per imparare ad osservare. La meditazione aiuta a mantenere la mente acuta e ti introduce anche a cosa significa essere “completamente concentrato sul mondo che ti circonda”.
- La meditazione non è necessariamente qualcosa di straordinario. Tutto ciò di cui hai bisogno sono pochi minuti al giorno senza farti distrarre da nulla, imparando a focalizzare la tua attenzione – magari immaginando mentalmente qualche immagine, magari su qualche immagine di fronte a te. Il punto è lasciare che qualunque cosa tu stia meditando occupi tutta la tua attenzione.
-
Mettiti alla prova. Quale modo migliore per affinare le tue capacità di osservazione se non una sfida?! Una volta al giorno, una settimana e un mese, poniti un enigma che deve essere risolto, ma che richiederà tutta la tua forza e capacità di osservazione per essere risolto.
- Diciamo che puoi impostarti qualcosa come un compito per osservare qualcosa di nuovo ogni giorno, ad esempio, scattare una foto da una prospettiva diversa una volta al giorno. Le foto dovrebbero mostrare oggetti familiari da una nuova prospettiva.
- Un altro esercizio utile è osservare le persone. Nota le piccole cose: vestiti, andatura. Col tempo, sarai anche in grado di notare dettagli come le emozioni di una persona rivelate attraverso il linguaggio del corpo.
-
Prendi nota. Sì, Holmes non portava con sé una penna e un taccuino, ma quello era Holmes. Stai ancora imparando, quindi sarà molto difficile senza appunti. Se prendi appunti, scrivi tutto in dettaglio in modo da poter ricordare in seguito i luoghi, i suoni e gli odori.
- Il processo di registrazione delle osservazioni ti aiuterà a imparare a prestare attenzione ai dettagli. Col tempo raggiungerai un livello di sviluppo oltre il quale non avrai più bisogno degli appunti. Fino ad allora... continua a scrivere!
Parte 2
Sviluppare il pensiero deduttivo-
Fare domande. Guarda tutto con una sana dose di scetticismo e continua a fare domande su ciò che osservi, pensi e senti. Non accontentarti della risposta più ovvia, abituati a scomporre il problema nelle sue componenti, risolvile separatamente: così arriverai alla soluzione giusta.
- Prima di “mettere” qualcosa di nuovo nella memoria, analizzalo con domande. Chiediti perché questo è importante, vale la pena ricordarlo e come si collega a ciò che già sai.
- Per fare le domande giuste bisogna studiare, studiare e studiare ancora un po’. La capacità di leggere attentamente e comprendere ciò che leggi, per non parlare di una solida base di conoscenza, ti aiuterà molto. Studia argomenti importanti, sperimenta cose che ti interessano, prendi appunti su come pensi. Più sai, più è probabile che la domanda che ti viene posta sia corretta e importante.
-
Ricorda la differenza tra l'impossibile e l'improbabile. La stessa natura umana ti spingerà a considerare l’improbabile come impossibile. Tuttavia, se esiste una possibilità, è necessario tenerne conto. Solo ciò che è veramente impossibile può essere ignorato.
-
La tua mente deve essere aperta. Dimentica i tuoi pregiudizi quando osservi una situazione, dimentica i tuoi pregiudizi quando analizzi una situazione! Ciò che pensi o senti è una cosa. Ciò che sai è diverso e molto più importante. L'intuizione è importante, ovviamente, ma è necessario trovare un equilibrio tra logica e intuizione.
- Se non hai tutte le prove o le prove a portata di mano, non affrettarti a trarre conclusioni. Se fai un'ipotesi prima di aver analizzato tutti i fatti, molto probabilmente la tua ipotesi sarà errata e ciò ti impedirà notevolmente di arrivare al fondo della verità.
- Le teorie devono essere adattate ai fatti, non i fatti alle teorie. Raccogli i fatti e scarta tutte le teorie che contraddicono i fatti ricevuti. Non dare per scontato ciò che è reale solo in teoria, ma non nei fatti, soprattutto se sei spinto dal desiderio di distorcere i fatti a favore di una teoria passata.
-
Connettiti con colleghi fidati. Perfino Holmes, un genio riconosciuto, non poteva vivere senza Watson quando si trattava di discutere idee. Trova qualcuno di cui ti fidi dell'intelligenza e discuti con lui le tue osservazioni e conclusioni.
- È molto importante consentire all'altra persona di elaborare teorie o conclusioni senza rinunciare a informazioni che sai essere vere.
- Se dalla discussione emergono nuove idee che cambiano la tua teoria, così sia: non lasciare che l'orgoglio si intrometta tra te e la verità!
-
Concediti una pausa.È improbabile che il tuo cervello resista a lungo al lavoro in modalità "Sherlock Holmes". Anche Holmes si prendeva delle pause! Sai, sparare, suonare il violino, morfina... Concedere un po' di riposo alla mente migliorerà notevolmente la tua capacità di ottenere le risposte giuste e giungere alle giuste conclusioni, soprattutto a lungo termine.
- Se ti concentri troppo sul problema, ti stancherai e non sarai più in grado di analizzare le informazioni con la stessa attenzione. La mattina, come si suol dire, è più saggia della sera. Tornando al problema con la mente lucida, potrai subito notare davanti a te il fatto più importante che il giorno prima era sfuggito alla tua attenzione!
Parte 3
Costruisci il tuo palazzo mentale-
Quali sono i benefici dei palazzi mentali? Il fatto è che puoi organizzare le informazioni nel modo più conveniente per te da ricordare e utilizzare. Holmes aveva i palazzi della ragione ma, a dire il vero, questa tradizione non è iniziata con lui.
- A rigor di termini, questo metodo è chiamato “metodo Lozi”. Loci è la forma plurale della parola latina che significa luogo (locus - loci). Questo metodo era utilizzato dagli antichi romani e prima di loro dagli antichi greci.
- L'essenza del metodo è che fatti e informazioni vengono ricordati in base al principio di associazione con un luogo realmente esistente.
Impara la differenza tra vedere e osservare. Watson, ad esempio, osservava. Holmes - guardato. Potresti aver sviluppato l'abitudine di guardare senza elaborare mentalmente le informazioni che ricevi. Di conseguenza, il primo passo verso il pensiero di Holmes è la capacità di osservare e comprendere tutti i dettagli di ciò che sta accadendo.
Sii concentrato e completamente concentrato.È necessario conoscere i propri limiti. Purtroppo, il cervello umano non è progettato per eseguire diversi compiti complessi contemporaneamente. Se vuoi imparare ad osservare in modo intelligente, è improbabile che tu possa fare una dozzina di cose in più che ti distrarranno solo dall'osservazione.
Pagina corrente: 1 (il libro ha 20 pagine in totale) [passaggio di lettura disponibile: 12 pagine]
Annotazione
È possibile imparare a pensare in modo chiaro e razionale come Sherlock Holmes, o la sua logica impeccabile e la chiarezza cristallina della mente sono solo un'invenzione dello scrittore?
Sì, Maria Konnikova, famosa psicologa e giornalista americana, ne è convinta. Esaminando episodi tratti dai libri di Conan Doyle alla luce delle moderne neuroscienze e psicologia, rivela, passo dopo passo, in modo semplice e coinvolgente, le strategie mentali che portano a un pensiero lucido e a una profonda comprensione di fenomeni e fatti. Il libro descrive come, seguendo l'esempio del grande detective, con il desiderio e un po' di allenamento possiamo affinare la nostra percezione, sviluppare la logica e la creatività.
Traduzione: Ulyana Saptsina
Maria Konnikova
introduzione
Maria Konnikova
Mente straordinaria: pensare come Sherlock Holmes
...
È divertente, ma il libro di Maria Konnikova, affascinante e talvolta provocatorio, ti fa davvero riflettere su come pensiamo.
Recensione del libro
...
Questo è un libro estremamente utile, basato sulle conquiste della psicologia moderna e pieno di esempi tratti dalla vita moderna. Ti aiuterà a trovare un linguaggio comune con il tuo Holmes interiore e trascorrerà più di un'ora con lui su un'accogliente sedia accanto al caminetto, osservando e traendo conclusioni.
Globo di Boston
...
Il nuovo libro di Maria Konnikova non è affatto “elementare”: è uno studio pertinente e ponderato della mente umana, integrato da esempi tratti dalla vita e dal lavoro professionale di Sherlock Holmes. Lo stesso Holmes sarebbe orgoglioso se diventasse l'autore di un'opera così meravigliosa!
Settimanale degli editori
...
Il nuovo libro brillante e talentuoso di Maria Konnikova non è altro che un libro di testo sul risveglio della coscienza, una guida per sbarazzarsi dei pregiudizi del subconscio, dell'abitudine alla distrazione e della confusione dei nostri pensieri quotidiani. Anche quei lettori che non considerano Holmes il loro idolo troveranno il libro stimolante, coinvolgente e, soprattutto, benefico.
L'indipendente
Dedicato a Jeff
La scelta degli oggetti di attenzione - la capacità di prestare attenzione ad alcuni e trascurarne altri - occupa lo stesso posto nelle manifestazioni interne della vita della scelta delle azioni - in quelle esterne. In entrambi i casi, una persona è responsabile della sua scelta ed è costretta a sopportarne le conseguenze. Come diceva Ortega y Gasset, “dimmi a cosa presti attenzione e ti dirò chi sei”.
W. H. Auden
introduzione
Quando ero piccola, prima di andare a letto, mio padre ci leggeva storie su Sherlock Holmes. Mio fratello, cogliendo l'occasione, si addormentò subito nel suo angolo del divano, ma noi altri pendevamo da ogni parola. Ricordo la grande poltrona di pelle su cui sedeva papà, tenendo un libro davanti a sé con una mano, e ricordo come le fiamme che danzavano nel camino si riflettevano nelle lenti dei suoi occhiali dalla montatura nera. Ricordo come alzava e abbassava la voce, aumentando la tensione prima di ogni colpo di scena e, infine, la soluzione tanto attesa, quando tutto improvvisamente aveva un senso, e io scossi la testa, proprio come il dottor Watson, e pensai: " Beh, certo! Com’è semplice ora che ha spiegato tutto!” Ricordo l'odore della pipa che papà fumava così spesso, il modo in cui il fumo dolce di una miscela di tabacco grezzo si depositava tra le pieghe di una sedia di pelle, ricordo le forme notturne dietro le tende e la porta a vetri. La pipa di papà, ovviamente, era leggermente curva, esattamente come quella di Holmes. Ricordo anche il suono finale del libro che si chiudeva sbattendo, quando le pagine venivano rimesse insieme sotto le copertine cremisi della rilegatura, e papà annunciava: “Per oggi è tutto”. E ci siamo lasciati: era inutile implorare, implorare e fare smorfie pietose - di sopra e a letto.
E allora un altro dettaglio rimase impresso nella mia memoria - così profondamente che vi rimase, senza darmi tregua, anche molti anni dopo, quando il resto delle storie svanì, fondendosi con uno sfondo sfocato e le avventure di Holmes e dei suoi devoti biografo furono dimenticati tutti. Questo dettaglio sono i passaggi.
I gradini del 221B di Baker Street. Quanti erano? Holmes ha chiesto a Watson di questo in A Scandal in Bohemia, e la sua domanda mi è sempre rimasta in testa. Holmes e Watson sono seduti uno accanto all'altro sulle poltrone, il detective spiega al medico come la capacità di guardare semplicemente differisce dalla capacità di notare. Watson è perplesso. E poi all'improvviso tutto diventa completamente chiaro.
...
"Quando ascolto il tuo ragionamento", ha osservato Watson, "tutto mi sembra ridicolmente semplice, al punto che io stesso avrei indovinato senza difficoltà, ma in ogni singolo caso sono perplesso finché non spieghi il corso dei tuoi pensieri . Tuttavia sono convinto che il mio occhio è acuto quanto il tuo.
"Esattamente", rispose Holmes, accendendosi una sigaretta e appoggiandosi allo schienale della sedia. – Vedi, ma non te ne accorgi. La differenza è ovvia. Ad esempio, vedi spesso dei gradini che conducono dal corridoio a questa stanza.
- Spesso.
- Quante volte li hai già visti?
- Diverse centinaia.
- E quanti gradini ci sono?
– Un passo?..non lo so.
- Esattamente! Non te ne sei accorto. Anche se li abbiamo visti. E' di questo che stiamo parlando. E so che lì ci sono diciassette gradini, perché li ho visti e li ho notati”.
Rimasi scioccato da questo dialogo, ascoltato una sera alla luce del camino, quando nell'aria aleggiava il fumo della pipa. Cercavo freneticamente di ricordare quanti gradini c'erano in casa nostra (non ne avevo idea), quanti portavano alla nostra porta d'ingresso (di nuovo nessuna risposta), e quanti conducevano al seminterrato (dieci? Venti? Non ci riuscivo). non fornire nemmeno un numero approssimativo). Per molto tempo ho provato a contare i passi di tutte le scale che incontravo e a ricordare i risultati ottenuti, nel caso qualcuno mi chiedesse un resoconto. Holmes sarebbe fiero di me.
Naturalmente, ho dimenticato quasi immediatamente ogni numero che ho cercato così duramente di ricordare - solo molto più tardi mi sono reso conto che concentrandomi interamente sulla memorizzazione, stavo perdendo di vista la vera essenza del problema. I miei sforzi sono stati vani fin dall’inizio.
All'epoca non avevo realizzato che Holmes avesse un vantaggio significativo su di me. Ha trascorso gran parte della sua vita ad affinare il suo metodo di interazione ponderata con il mondo che lo circonda. E i gradini della casa di Baker Street sono solo un modo per dimostrare un'abilità che usava con naturalezza, senza pensare. Una delle manifestazioni di un processo che abitualmente e quasi inconsciamente avviene nella sua mente sempre attiva. Se preferisci, un trucco che non ha alcuno scopo pratico e allo stesso tempo pieno di significato più profondo, devi solo pensare a cosa lo ha reso possibile. Un trucco che mi ha ispirato a scrivere un intero libro a riguardo.
L’idea di premurosità non è affatto nuova. Indietro alla fine del 19° secolo. il padre della psicologia moderna, William James, scriveva che “la capacità di focalizzare consapevolmente l'attenzione errante, facendolo ancora e ancora, è il primo fondamento del giudizio, del carattere e della volontà... La migliore educazione è quella che sviluppa questa capacità. " L'abilità menzionata stessa è la quintessenza della premurosità. E l'educazione proposta da James insegna un approccio ponderato alla vita e al pensiero.
Negli anni '70 XX secolo Ellen Langer ha dimostrato che la premurosità può fare molto di più che cambiare semplicemente “giudizio, carattere e volontà”. Praticando la consapevolezza, gli anziani si sentono addirittura più giovani e agiscono di conseguenza, un approccio che migliora i loro segni vitali, come la pressione sanguigna, e la funzione cognitiva. Le ricerche degli ultimi anni hanno dimostrato: la meditazione-riflessione (esercizi per il controllo completo dell'attenzione, che costituisce la base della riflessione), se eseguita per soli quindici minuti al giorno, modifica gli indicatori di attività dei lobi frontali del cervello in una direzione più caratteristico di uno stato emotivo positivo e attenzione ai risultati, in altre parole, anche un breve periodo di contemplazione della natura può renderci più perspicaci, creativi e produttivi. Inoltre, ora possiamo affermare con grande certezza: il nostro cervello non è progettato per il multitasking, il che esclude completamente la riflessione. Quando siamo costretti a fare molte cose contemporaneamente, non solo affrontiamo peggio tutti questi compiti: la nostra memoria si deteriora e il nostro benessere generale ne risente notevolmente.
Ma per Sherlock Holmes la presenza premurosa è solo il primo passo. Suggerisce uno scopo molto più significativo, utilitaristico e gratificante. Holmes raccomanda ciò che William James raccomandava: imparare a sviluppare le nostre capacità di pensiero riflessivo e metterle in pratica in modo da poter ottenere di più, pensare meglio e prendere decisioni migliori più spesso. In altre parole, si tratta di migliorare la nostra capacità di prendere decisioni e costruire inferenze, a partire dalle fondamenta, dagli elementi costitutivi che compongono la nostra mente.
Contrastando la capacità di vedere con la capacità di notare, Holmes spiega infatti a Watson che in nessun caso si dovrebbe confondere la spensieratezza con la premurosità, o confondere un approccio passivo con un coinvolgimento attivo. La nostra vista funziona in modo automatico: questo flusso di informazioni sensoriali non richiede alcuno sforzo da parte nostra, dobbiamo solo tenere gli occhi aperti. E vediamo senza pensare, assorbiamo innumerevoli elementi del mondo circostante, senza degnare ciò che vediamo con la necessaria elaborazione da parte del cervello. A volte non siamo nemmeno consapevoli di ciò che è davanti ai nostri occhi. Per notare qualcosa, devi concentrare la tua attenzione. Per fare ciò è necessario passare dall'assorbimento passivo delle informazioni alla loro percezione attiva. Cioè, lasciati coinvolgere consapevolmente in esso. Ciò vale non solo per la vista, ma per tutti i sensi, per tutte le informazioni in arrivo e per ogni pensiero.
Troppo spesso trattiamo la nostra mente con sorprendente sconsideratezza. Seguiamo il flusso, inconsapevoli di quanto ci manca nel nostro processo di pensiero, e non abbiamo idea di quanto trarremmo beneficio dal prenderci del tempo per capirlo e dargli un senso. Come Watson, percorriamo le stesse scale decine, centinaia, migliaia di volte, più volte al giorno, ma non cerchiamo di ricordare nemmeno le caratteristiche più semplici di questa scala (non mi sorprenderei se Holmes non chiedesse della numero di passi, ma del loro colore e scopro che anche questo dettaglio è passato inosservato a Watson).
Non è che siamo incapaci di ricordare: è solo che noi stessi preferiamo non farlo. Ricorda la tua infanzia. Se ti chiedessi di parlare della strada in cui sei cresciuto, è probabile che ricorderesti moltissimi dettagli: il colore delle case, le stranezze dei vicini. Odori in diversi periodi dell'anno. Come appariva la strada nelle diverse ore del giorno. Luoghi dove hai giocato e dove sei passato. E dove si guardavano bene dall'andare. Ti garantisco che la storia durerebbe per ore.
Da bambini siamo estremamente sensibili. Assorbiamo ed elaboriamo le informazioni a una velocità che non possiamo nemmeno sognare in futuro. Nuovi panorami, nuovi suoni e odori, nuove persone, emozioni, impressioni: impariamo a conoscere il nostro mondo e le sue possibilità. Tutto intorno è nuovo, tutto è interessante, tutto suscita curiosità. È proprio per questa novità di tutto ciò che ci circonda che siamo sensibili e vigili, siamo concentrati e non ci lasciamo sfuggire nulla. Inoltre, grazie alla motivazione e al coinvolgimento (due qualità su cui torneremo più di una volta), non solo percepiamo il mondo in modo più completo di quanto faremo in seguito, ma immagazziniamo anche informazioni per un uso futuro. Chissà cosa potrebbe tornare utile e quando?
Man mano che invecchiamo, la nostra sazietà cresce in modo esponenziale. Ci siamo già passati, abbiamo già affrontato tutto questo, non c'è bisogno di prestarci attenzione e ne avrò mai bisogno? Prima che ce ne rendiamo conto, perdiamo la nostra naturale attenzione, passione e curiosità e soccombiamo all’abitudine alla passività e alla sconsideratezza. E anche quando vogliamo lasciarci trasportare da qualcosa, si scopre che questo lusso, così accessibile durante l'infanzia, ci è già stato negato. Sono finiti i giorni in cui il nostro compito principale era imparare, assorbire, interagire; Ora abbiamo altre responsabilità, più rilevanti (come ci sembra), la nostra mente deve servire altri bisogni. E man mano che la richiesta della nostra attenzione aumenta – il che è allarmante nell’era digitale, quando al cervello è richiesto di risolvere molteplici compiti paralleli ventiquattro ore al giorno, sette giorni alla settimana – la nostra attenzione in realtà diminuisce. Così facendo, perdiamo gradualmente la capacità di riflettere o di notare le nostre abitudini mentali e permettiamo sempre più alla nostra mente di dettare i nostri giudizi e decisioni piuttosto che fare il contrario. Non c’è niente di sbagliato in questo fenomeno in sé – menzioneremo la necessità di automatizzare alcuni processi inizialmente difficili e cognitivamente costosi – ma ci avvicina pericolosamente all’insensatezza. Il confine tra destrezza e meccanicità sconsiderata è sottile, e qui bisogna stare estremamente attenti per non oltrepassarlo accidentalmente.
Probabilmente hai riscontrato situazioni in cui devi rinunciare a muoverti su una pista zigrinata e all'improvviso si scopre che hai dimenticato come farlo. Diciamo che tornando a casa devi fermarti in farmacia. Ti sei ricordato di questo compito imminente tutto il giorno. Hai provato nella tua mente, immaginando dove girare di nuovo per arrivare dove devi andare, deviando solo leggermente dal tuo solito percorso. E ora ti ritrovi vicino alla casa, senza nemmeno ricordare che saresti andato da qualche altra parte. Ti sei dimenticato di fare una svolta in più, sei passato oltre e non ti è passato per la testa il minimo pensiero. È intervenuta l'insensatezza nata dall'abitudine, e la routine ha sopraffatto la parte del cervello che sapeva che avevi in programma un'altra cosa.
Questo succede continuamente. Siamo così presi dalla routine che trascorriamo metà della giornata in uno stupore insensato. (Stai ancora pensando al lavoro? Preoccupato per un'e-mail? Pianificare la cena in anticipo? Lascia perdere!) Questa dimenticanza automatica, questo potere della routine, questa facilità con cui siamo pronti a distrarci è ancora una sciocchezza, anche se evidente (visto che siamo data l’opportunità di renderci conto che ci siamo dimenticati di fare qualcosa), questa piccola cosa è solo una piccola parte di un fenomeno molto più ampio. Quanto sopra accade più spesso di quanto pensiamo: raramente ci rendiamo conto della nostra sconsideratezza. Quanti pensieri nascono nella nostra mente e si dissipano prima che riusciamo a coglierli? Quante idee e intuizioni ci sfuggono perché dimentichiamo di prestare loro attenzione? Quante decisioni prendiamo senza renderci conto di come o perché le abbiamo prese, guidati da alcune impostazioni interne “predefinite” – impostazioni di cui siamo vagamente consapevoli o non sospettiamo affatto? Quante volte ci capita di avere giorni in cui improvvisamente riprendiamo i sensi e ci chiediamo cosa abbiamo fatto e come siamo arrivati a questo punto della vita?
Lo scopo di questo libro è aiutarti. Usando i principi di Holmes come esempio, esamina e spiega i passi che devi compiere per sviluppare l'abitudine di un contatto premuroso con te stesso e il mondo che ti circonda. Affinché anche tu possa menzionare con disinvoltura il numero esatto di gradini delle scale, tra lo stupore di un interlocutore meno attento. Quindi, accendi il camino, siediti comodamente sul divano e preparati a prendere parte ancora una volta alle avventure di Sherlock Holmes e il dottor Watson nelle strade infestate dalla criminalità di Londra e nei recessi più nascosti della mente umana.
Parte 1 CAPIRE TE STESSO
Capitolo 1 IL METODO SCIENTIFICO DI PENSARE
Qualcosa di terribile stava accadendo al bestiame nelle fattorie di Great Wyerley. Pecore, mucche e cavalli morirono uno dopo l'altro nel cuore della notte. Ogni volta la causa della morte era una ferita lunga e superficiale sul ventre, dalla quale l'animale sanguinava lentamente e dolorosamente. Chi poteva pensare di provocare tanto dolore a creature indifese?
La polizia ha deciso che la risposta era nota: George Edalji, figlio di un parroco locale, un mezzosangue indiano. Nel 1903, il ventisettenne Edalji fu condannato a sette anni di lavori forzati per una delle sedici mutilazioni inflitte a un pony il cui corpo fu ritrovato in una cava vicino alla canonica. Il giuramento del vicario secondo cui suo figlio stava dormendo al momento del delitto non ha influito sul verdetto. Oltre al fatto che gli omicidi continuarono dopo che George fu preso in custodia. E che le prove si basavano in gran parte su lettere anonime attribuite a George, lettere che lo implicavano come l'assassino. La polizia, guidata dal capitano George Anson, capo della polizia dello Staffordshire, era convinta che il colpevole fosse stato trovato.
Tre anni dopo, Edalji fu rilasciato. Due petizioni sono state inviate al Ministero degli Interni britannico per dichiarare l'innocenza di Edalji: una firmata da diecimila persone, la seconda da trecento avvocati, e gli autori di entrambi i messaggi hanno fatto riferimento alla mancanza di prove in questo caso. Tuttavia, la storia non è finita qui. Edalji è stato rilasciato, ma il suo nome era ancora offuscato. Prima del suo arresto era avvocato giurato. Non aveva il diritto di riprendere la pratica legale dopo il suo rilascio.
Nel 1906 Edalji ebbe fortuna: Arthur Conan Doyle si interessò al suo caso. Quello stesso inverno, Conan Doyle organizzò un incontro con Edalji al Grand Hotel di Charing Cross. Se Conan Doyle aveva dei dubbi sull'innocenza di Edalji, questi venivano dissipati nella hall dell'hotel. Come scrisse più tardi Conan Doyle,
...
“...è venuto in albergo come concordato, ma io sono rimasto fino a tardi e lui passava il tempo leggendo il giornale. Riconoscendolo da lontano dal suo volto scuro, mi fermai e lo osservai per qualche tempo. Teneva il giornale troppo vicino agli occhi e anche inclinato, il che indicava non solo una grave miopia, ma anche un pronunciato astigmatismo. L’idea stessa di una persona del genere che vagava di notte per i campi e aggrediva il bestiame, cercando di non farsi prendere dalla polizia, sembrava ridicola… Quindi, già in questo unico difetto fisico risiedeva la certezza morale della sua innocenza”.
Ma, nonostante la propria convinzione, Conan Doyle sapeva che ciò non era sufficiente e sarebbe stato molto più difficile attirare l'attenzione del Ministero degli affari interni su questo caso. Ed è andato a Great Wyrely per raccogliere prove rilevanti per il caso. Ha interrogato i residenti locali, esaminato le scene del crimine, studiato prove e circostanze. Ha affrontato la crescente ostilità del capitano Anson. Ho visitato la scuola dove ha studiato George. Ha tirato fuori informazioni di vecchia data su lettere anonime e scherzi che avevano preso di mira la stessa famiglia. Ho trovato un esperto di grafia che aveva precedentemente annunciato che la grafia di Edalji coincideva con quella in cui erano scritti i messaggi anonimi. E infine ha presentato il materiale raccolto al Ministero degli Interni.
Lame insanguinate? In realtà sono vecchi e arrugginiti, in ogni caso non possono provocare ferite come quelle di cui soffrivano gli animali. Argilla sui vestiti di Edalji? La composizione è diversa da quella del campo in cui è stato scoperto il pony. Esperto di scrittura? Era già giunto a conclusioni errate, con il risultato che i verdetti di colpevolezza sono stati emessi contro persone innocenti. E, naturalmente, c'è il problema della vista: come potrebbe una persona che soffre di grave astigmatismo e, inoltre, di miopia, navigare di notte nei campi dove venivano uccisi gli animali?
Nella primavera del 1907, Edalji fu finalmente prosciolto dalle accuse di crudeltà nell'uccisione di animali. Conan Doyle non ottenne mai la vittoria completa che sperava - George non fu risarcito in alcun modo per il tempo trascorso agli arresti e in prigione - ma fu comunque un successo. Edalji ha ripreso la sua pratica legale. Come ha riassunto Conan Doyle, la commissione d’inchiesta ha constatato che “la polizia aveva riaperto le indagini e le aveva portate avanti con l’obiettivo di trovare non il colpevole, ma le prove contro Edalji, della cui colpevolezza erano convinti fin dall’inizio”. Nell'agosto dello stesso anno apparve in Inghilterra la prima corte d'appello, il cui compito era controllare i casi di violazioni nell'amministrazione della giustizia. Il caso Edalji è considerato uno dei motivi principali per la creazione di tali tribunali.
L'incidente ha lasciato un'impressione indelebile sugli amici di Conan Doyle, ma lo scrittore George Meredith ha espresso meglio le sue impressioni. "Non menzionerò il nome di cui probabilmente sei stufo", ha detto Meredith a Conan Doyle, "ma il creatore dell'immagine di un brillante investigatore privato ha dimostrato personalmente di essere capace di qualcosa". Sherlock Holmes può essere frutto dell'immaginazione, ma il suo approccio meticoloso al pensiero è molto reale. Se applicato correttamente, il suo metodo può uscire dalle pagine di un libro e produrre risultati positivi tangibili, e non solo nelle indagini sui crimini.
Basta pronunciare il nome di Sherlock Holmes e vengono in mente molte immagini. Un tubo. Berretto da caccia con cuffie. Mantello. Violino. Profilo del falco. Forse il volto di William Gillett, Basil Rathbone, Jeremy Brett o altre celebrità che hanno interpretato Holmes, come Benedict Cumberbatch e Robert Downey Jr. Qualunque immagine appaia davanti agli occhi della tua mente, presumo che non abbiano nulla a che fare con la parola “psicologo”. Comunque è il momento di dirlo.
Holmes era un detective consumato, questo è certo. Ma la sua comprensione delle peculiarità del pensiero umano supera le sue imprese più significative nel campo delle forze dell'ordine. Sherlock Holmes offre molto più di un semplice modo per risolvere i crimini. Il suo approccio è applicabile ben oltre le strade della nebbiosa Londra. Va oltre sia la scienza che l'azione investigativa e può servire da modello di pensiero e persino di esistenza, efficace oggi come lo era ai tempi di Conan Doyle. Sono disposto a scommettere che questo è il segreto del fascino implacabile, sorprendente e universale di Holmes.
Quando lo creò, Conan Doyle aveva una bassa opinione del suo personaggio. È improbabile che fosse guidato dall'intenzione di presentare un modello di pensiero, processo decisionale e arte di formulare e risolvere problemi. Tuttavia, questo è esattamente il campione che ha ottenuto. In effetti, Conan Doyle creò l'esponente ideale delle idee rivoluzionarie nella scienza e nel modo di pensare: una rivoluzione che si svolse nei decenni precedenti e continuò all'alba del nuovo secolo. Nel 1887 apparve Holmes: un detective di un nuovo tipo, un pensatore senza precedenti, un esempio di un uso senza precedenti del potere della ragione. Oggi Holmes funge da standard per pensare in modo più efficace di quanto diamo per scontato.
Sherlock Holmes era un visionario in molti sensi. Le sue spiegazioni, la sua metodologia e l'intero approccio al processo di pensiero hanno anticipato lo sviluppo della psicologia e della neurobiologia con un centinaio di anni di anticipo e sono stati rilevanti per più di ottant'anni dopo la morte del suo creatore. Ma in qualche modo il modo di pensare di Holmes sembra inevitabilmente un puro prodotto del suo tempo e del suo posto nella storia. Se il metodo scientifico ha dimostrato i suoi meriti in tutti i tipi di attività scientifiche e di altro tipo - dalla teoria dell'evoluzione alla radiografia, dalla relatività generale alla scoperta dei microrganismi patogeni e all'anestesia, dal comportamentismo alla psicoanalisi - allora perché non dovrebbe manifestarsi in i principi del pensiero stesso?
Secondo lo stesso Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes era originariamente destinato a diventare la personificazione dell'approccio scientifico, un ideale al quale tendere, anche se non potrà mai essere riprodotto esattamente (del resto, a cosa servono gli ideali se non a restare fuori portata?). Il nome stesso Holmes indica immediatamente che l'intenzione dell'autore non era quella di creare una semplice immagine di un detective nello spirito dei tempi passati: molto probabilmente, Conan Doyle scelse di proposito il nome per il suo eroe, come omaggio a uno dei suoi idoli d'infanzia. , il medico e filosofo Oliver Wendell Holmes Sr., noto sia per il suo lavoro che per i suoi risultati pratici. Il prototipo della personalità del famoso detective fu un altro mentore di Conan Doyle, il dottor Joseph Bell, un chirurgo famoso per la sua capacità di osservazione. Si diceva che il dottor Bell potesse dire con una sola occhiata che il paziente era un sergente recentemente congedato del reggimento delle Highland che aveva appena prestato servizio alle Barbados, e che il dottor Bell testava regolarmente l'intuizione dei suoi studenti usando metodi che includevano l'auto-sperimentazione con varie sostanze tossiche, cose familiari a tutti coloro che hanno letto attentamente le storie su Holmes. Come scrisse Conan Doyle al dottor Bell: “Attorno al nucleo della deduzione, dell’inferenza e dell’osservazione, che ti ho sentito praticare, ho cercato di creare l’immagine di un uomo che è andato il più lontano possibile in queste cose, e talvolta anche oltre." quello conta, dopo di lui: questo detective ha elevato l'arte dell'investigazione al livello di scienza esatta.
La quintessenza dell'approccio inerente a Sherlock Holmes ci viene presentata nella storia "Uno studio in rosso", in cui il detective appare per la prima volta davanti al lettore. Diventa presto chiaro che per Holmes ogni caso non è semplicemente un caso come appare alla polizia di Scotland Yard (un delitto, una serie di fatti, più persone coinvolte, una sintesi di informazioni - tutto questo con lo scopo di portare il criminale alla giustizia), ma allo stesso tempo qualcosa di più, e di meno. Di più, perché in questo caso la questione acquista un significato più ampio e generale, come oggetto di studio e riflessione su larga scala, diventando, se si vuole, un compito scientifico. Le sue linee generali sono inevitabilmente visibili nei compiti precedenti e saranno senza dubbio ripetute in quelli futuri. I principi generali si applicano ad altri punti, a prima vista, non correlati. Meno - perché la questione viene spogliata delle sue componenti emotive e ipotetiche - elementi che offuscano la chiarezza del pensiero - e diventa oggettiva quanto può esserlo una realtà al di fuori della scienza. Risultato: la criminalità è un argomento di ricerca strettamente scientifica, che dovrebbe essere affrontato sulla base di principi metodologici scientifici. E la mente umana è la loro serva. Cos’è il “metodo di pensiero scientifico”?
Quando si parla di metodo scientifico, siamo soliti immaginare uno scienziato sperimentale in un laboratorio – magari con una provetta in mano e un camice bianco – che segue una sequenza di azioni che va più o meno così: fare alcune osservazioni legate a qualche fenomeno; sviluppare un'ipotesi per spiegare queste osservazioni; progettare un esperimento per verificare questa ipotesi; condurre un esperimento; vedere se i risultati soddisfano le aspettative; se necessario, affinare l'ipotesi; lavare, risciacquare e ripetere. Sembra abbastanza semplice. Ma come puoi fare qualcosa di più difficile? È possibile allenare la mente ad agire automaticamente in questo modo ogni volta?
Holmes consiglia di iniziare dalle basi. Come dice quando lo incontriamo per la prima volta, “prima di passare agli aspetti morali e intellettuali della questione, che presentano le maggiori difficoltà, l’investigatore inizi con la soluzione dei problemi più semplici”. Il metodo scientifico si basa sulla più prosaica delle azioni: l'osservazione. Prima ancora di porre le domande che determinano il corso di un'indagine o di un esperimento scientifico, o anche solo di prendere una decisione apparentemente semplice - se invitare o meno uno dei tuoi amici a cena - è necessario preparare il terreno, fare qualche lavoro preliminare. Non c’è da stupirsi che Holmes definisca “elementari” i fondamenti della sua ricerca. Perché lo sono davvero, queste sono le basi della struttura e dei principi di funzionamento di ogni cosa nel mondo.
Non tutti gli scienziati si rendono conto di quali siano queste basi: sono così saldamente radicate nel suo modo di pensare. Quando un fisico propone un nuovo esperimento o un chimico decide di indagare sulle proprietà di un composto appena ottenuto, non sempre è consapevole che la sua domanda specifica, il suo approccio, la sua ipotesi, le sue stesse idee su ciò che sta facendo, sarebbero impossibile senza quelle esistenti Ha a disposizione le conoscenze elementari accumulate negli anni. Inoltre, sarà difficile per questo scienziato spiegarti dove esattamente gli è venuta l'idea per la ricerca e perché inizialmente ha deciso che avesse senso.
Dopo la seconda guerra mondiale, il fisico Richard Feynman fu invitato a far parte di una commissione statale sui programmi di studio per selezionare libri di testo di scienze per gli studenti delle scuole superiori della California. Con sgomento di Feynman, i testi presentati avevano più probabilità di confondere gli studenti che di illuminarli. Ogni libro di testo successivo si è rivelato peggiore del precedente. Alla fine si imbatté in un inizio promettente: una serie di illustrazioni raffiguranti un giocattolo a carica, un'auto e un ragazzo in bicicletta. E sotto ogni firma: "Cosa mette in movimento questo oggetto?" Infine, pensò Feynman, ecco una spiegazione delle basi della scienza, a cominciare dalle basi della meccanica (giocattolo), della chimica (macchina) e della biologia (ragazzo). Ahimè, la sua gioia fu di breve durata. Dove si aspettava di trovare finalmente una spiegazione e una vera comprensione, vide le parole: "Questo oggetto è messo in movimento dall'energia". Ma cos'è? Perché l'energia fa muovere gli oggetti? Come fa? Queste domande non solo non hanno ricevuto risposta, ma non sono state nemmeno poste. Come ha detto Feynman, "Non significa niente... è solo una parola!" E continuava a ragionare: “Ciò che si dovrebbe fare è guardare un giocattolo a carica, vedere che ha delle molle all’interno, imparare a conoscere le molle e le ruote, e dimenticare l’energia. E solo allora, quando i bambini capiranno come funziona effettivamente il giocattolo, potremo discutere con loro i principi più generali dell’energia”.
Feynman è uno dei pochi che non ha dato per scontate le sue conoscenze di base, ma ha sempre ricordato i “mattoni” – gli elementi alla base di ogni problema e di ogni principio. Questo è esattamente ciò che intende Holmes quando ci spiega che dobbiamo iniziare dalle basi, con domande così banali che non ci degniamo di prestarvi attenzione. Come si può avanzare ipotesi ed elaborare teorie verificabili se non si sa in anticipo cosa e come osservare, se non si comprende la natura fondamentale del problema in questione, se non lo si scompone nei suoi principali aspetti? componenti? (La semplicità è ingannevole, come vedremo nei prossimi due capitoli.)
Il metodo scientifico parte da un'ampia base di conoscenze, dalla comprensione dei fatti e dalle linee generali del problema da risolvere. Nella storia "Uno studio in rosso" un compito del genere per Holmes diventa un mistero di omicidio in una casa abbandonata a Lauriston Gardens. Nel tuo caso, potremmo parlare di una decisione: cambiare professione o meno. Qualunque sia la specificità del problema, è necessario definirlo, formularlo mentalmente nel modo più specifico possibile, quindi colmare le lacune con l'aiuto dell'esperienza passata e delle osservazioni fatte nel presente. (Come ricorda Holmes agli ispettori Lestrade e Gregson, che non hanno notato la somiglianza dell'omicidio sotto inchiesta con quello commesso in precedenza: "Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Tutto è già successo.") Solo allora si potrà passare alla fase di elaborazione di un'ipotesi. A questo punto, il detective fa ricorso alla fantasia e delinea possibili linee di indagine a seconda del corso degli eventi, senza aggrapparsi alle spiegazioni più scontate (ad esempio, in Uno studio in rosso, la scritta “Rache” sul muro non significa necessariamente il nome non scritto “Rachel” ” – potrebbe benissimo rivelarsi la parola tedesca per “vendetta”) - e stai cercando di prevedere i probabili scenari dovuti al tuo cambio di lavoro. Inoltre, in entrambi i casi, le ipotesi non vengono avanzate a caso: tutti gli scenari e le spiegazioni si basano su conoscenze e osservazioni di base.
Metodo di pensiero scientifico
Qualcosa di terribile stava accadendo al bestiame nelle fattorie di Great Wyerley. Pecore, mucche e cavalli morirono uno dopo l'altro nel cuore della notte. Ogni volta la causa della morte era una ferita lunga e superficiale sul ventre, dalla quale l'animale sanguinava lentamente e dolorosamente. Chi poteva pensare di provocare tanto dolore a creature indifese?
La polizia ha deciso che la risposta era nota: George Edalji, figlio di un parroco locale, un mezzosangue indiano. Nel 1903, il ventisettenne Edalji fu condannato a sette anni di lavori forzati per una delle sedici mutilazioni inflitte a un pony il cui corpo fu ritrovato in una cava vicino alla canonica. Il giuramento del vicario secondo cui suo figlio stava dormendo al momento del delitto non ha influito sul verdetto. Oltre al fatto che gli omicidi continuarono dopo che George fu preso in custodia. E che le prove si basavano in gran parte su lettere anonime attribuite a George, lettere che lo implicavano come l'assassino. La polizia, guidata dal capitano George Anson, capo della polizia dello Staffordshire, era convinta che il colpevole fosse stato trovato.
Tre anni dopo, Edalji fu rilasciato. Due petizioni sono state inviate al Ministero degli Interni britannico per dichiarare l'innocenza di Edalji: una firmata da diecimila persone, la seconda da trecento avvocati, e gli autori di entrambi i messaggi hanno fatto riferimento alla mancanza di prove in questo caso. Tuttavia, la storia non è finita qui. Edalji è stato rilasciato, ma il suo nome era ancora offuscato. Prima del suo arresto era un avvocato giurato. Non aveva il diritto di riprendere la pratica legale dopo il suo rilascio.
Nel 1906 Edalji ebbe fortuna: Arthur Conan Doyle si interessò al suo caso. Quello stesso inverno, Conan Doyle organizzò un incontro con Edalji al Grand Hotel di Charing Cross. Se Conan Doyle aveva dei dubbi sull'innocenza di Edalji, questi venivano dissipati nella hall dell'hotel. Come scrisse più tardi Conan Doyle,
“...è venuto in albergo come concordato, ma io sono rimasto fino a tardi e lui passava il tempo leggendo il giornale. Riconoscendolo da lontano dal suo volto scuro, mi fermai e lo osservai per qualche tempo. Teneva il giornale troppo vicino agli occhi e anche inclinato, il che indicava non solo una grave miopia, ma anche un pronunciato astigmatismo. L’idea stessa di una persona del genere che vagava di notte per i campi e aggrediva il bestiame, cercando di non farsi prendere dalla polizia, sembrava ridicola… Quindi, già in questo unico difetto fisico risiedeva la certezza morale della sua innocenza”.
Ma, nonostante la propria convinzione, Conan Doyle sapeva che ciò non era sufficiente e sarebbe stato molto più difficile attirare l'attenzione del Ministero degli affari interni su questo caso. Ed è andato a Great Wyrely per raccogliere prove rilevanti per il caso. Ha interrogato i residenti locali, esaminato le scene del crimine, studiato prove e circostanze. Ha affrontato la crescente ostilità del capitano Anson. Ho visitato la scuola dove ha studiato George. Ha tirato fuori informazioni di vecchia data su lettere anonime e scherzi che avevano preso di mira la stessa famiglia. Ho trovato un esperto di grafia che aveva precedentemente annunciato che la grafia di Edalji coincideva con quella in cui erano scritti i messaggi anonimi. E infine ha presentato il materiale raccolto al Ministero degli Interni.
Lame insanguinate? In realtà sono vecchi e arrugginiti, in ogni caso non possono provocare ferite come quelle di cui soffrivano gli animali. Argilla sui vestiti di Edalji? La composizione è diversa da quella del campo in cui è stato scoperto il pony. Esperto di scrittura? Era già giunto a conclusioni errate, con il risultato che i verdetti di colpevolezza sono stati emessi contro persone innocenti. E, naturalmente, c'è il problema della vista: come potrebbe una persona che soffre di grave astigmatismo e, inoltre, di miopia, navigare di notte nei campi dove venivano uccisi gli animali?
Nella primavera del 1907, Edalji fu finalmente prosciolto dalle accuse di crudeltà nell'uccisione di animali. Conan Doyle non ottenne mai la vittoria completa che si aspettava - George non venne in alcun modo risarcito per il tempo trascorso agli arresti e in prigione - tuttavia fu un successo. Edalji ha ripreso la sua pratica legale. Come ha riassunto Conan Doyle, la commissione d’inchiesta ha constatato che “la polizia aveva riaperto le indagini e le aveva portate avanti con l’obiettivo di trovare non il colpevole, ma le prove contro Edalji, della cui colpevolezza erano convinti fin dall’inizio”. Nell'agosto dello stesso anno apparve in Inghilterra la prima corte d'appello, il cui compito era controllare i casi di violazioni nell'amministrazione della giustizia. Il caso Edalji è considerato uno dei motivi principali per la creazione di tali tribunali.

Illustrazione: Evgenia Barinova
L'incidente ha lasciato un'impressione indelebile sugli amici di Conan Doyle, ma lo scrittore George Meredith ha espresso meglio le sue impressioni. "Non menzionerò il nome di cui probabilmente sei stufo", ha detto Meredith a Conan Doyle, "ma il creatore dell'immagine di un brillante investigatore privato ha dimostrato personalmente di essere capace di qualcosa". Sherlock Holmes può essere frutto dell'immaginazione, ma il suo approccio meticoloso al pensiero è molto reale. Se applicato correttamente, il suo metodo può uscire dalle pagine di un libro e produrre risultati positivi tangibili, e non solo nelle indagini sui crimini.
Basta pronunciare il nome di Sherlock Holmes e vengono in mente molte immagini. Un tubo. Berretto da caccia con cuffie. Mantello. Violino. Profilo del falco. Forse il volto di William Gillett, Basil Rathbone, Jeremy Brett o altre celebrità che hanno interpretato Holmes, come Benedict Cumberbatch e Robert Downey Jr. Qualunque immagine appaia davanti agli occhi della tua mente, presumo che non abbiano nulla a che fare con la parola “psicologo”. Comunque è il momento di dirlo.
 Holmes era un detective consumato, questo è certo. Ma la sua comprensione delle peculiarità del pensiero umano supera le sue imprese più significative nel campo delle forze dell'ordine. Sherlock Holmes offre molto più di un semplice modo per risolvere i crimini. Il suo approccio è applicabile ben oltre le strade della nebbiosa Londra. Va oltre sia la scienza che l'azione investigativa e può servire da modello di pensiero e persino di esistenza, efficace oggi come lo era ai tempi di Conan Doyle. Sono disposto a scommettere che questo è il segreto del fascino implacabile, sorprendente e universale di Holmes.
Holmes era un detective consumato, questo è certo. Ma la sua comprensione delle peculiarità del pensiero umano supera le sue imprese più significative nel campo delle forze dell'ordine. Sherlock Holmes offre molto più di un semplice modo per risolvere i crimini. Il suo approccio è applicabile ben oltre le strade della nebbiosa Londra. Va oltre sia la scienza che l'azione investigativa e può servire da modello di pensiero e persino di esistenza, efficace oggi come lo era ai tempi di Conan Doyle. Sono disposto a scommettere che questo è il segreto del fascino implacabile, sorprendente e universale di Holmes.
Quando lo creò, Conan Doyle aveva una bassa opinione del suo personaggio. È improbabile che fosse guidato dall'intenzione di presentare un modello di pensiero, processo decisionale e arte di formulare e risolvere problemi. Tuttavia, questo è esattamente il campione che ha ottenuto. In effetti, Conan Doyle creò l'esponente ideale delle idee rivoluzionarie nella scienza e nel modo di pensare: una rivoluzione che si svolse nei decenni precedenti e continuò all'alba del nuovo secolo. Nel 1887 apparve Holmes: un nuovo tipo di detective, un pensatore senza precedenti, un esempio di un uso senza precedenti del potere della ragione. Oggi Holmes funge da standard per pensare in modo più efficace di quanto diamo per scontato.
Sherlock Holmes era un visionario in molti sensi. Le sue spiegazioni, la sua metodologia e l'intero approccio al processo di pensiero hanno anticipato lo sviluppo della psicologia e della neurobiologia con un centinaio di anni di anticipo e sono stati rilevanti per più di ottant'anni dopo la morte del suo creatore. Ma in qualche modo il modo di pensare di Holmes sembra inevitabilmente un puro prodotto del suo tempo e del suo posto nella storia. Se il metodo scientifico ha dimostrato i suoi meriti in tutti i tipi di attività scientifiche e non - dalla teoria dell'evoluzione alla radiografia, dalla relatività generale alla scoperta dei microrganismi patogeni e all'anestesia, dal comportamentismo alla psicoanalisi - allora perché non dovrebbe manifestarsi in i principi del pensiero stesso?
Secondo lo stesso Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes era originariamente destinato a diventare la personificazione dell'approccio scientifico, un ideale al quale tendere, anche se non potrà mai essere riprodotto esattamente (del resto, a cosa servono gli ideali se non a restare fuori portata?). Il nome stesso Holmes indica immediatamente che l'intenzione dell'autore non era quella di creare una semplice immagine di un detective nello spirito dei tempi passati: molto probabilmente, Conan Doyle scelse di proposito il nome per il suo eroe, come omaggio a uno dei suoi idoli d'infanzia. , il medico e filosofo Oliver Wendell Holmes Sr., noto sia per il suo lavoro che per i suoi risultati pratici. Il prototipo della personalità del famoso detective fu un altro mentore di Conan Doyle, il dottor Joseph Bell, un chirurgo famoso per la sua capacità di osservazione. Si diceva che il dottor Bell potesse dire con una sola occhiata che il paziente era un sergente recentemente congedato del reggimento delle Highland, fresco di servizio alle Barbados, e che il dottor Bell testava regolarmente l'intuizione dei suoi studenti, usando metodi che includevano l'auto-sperimentazione. con varie sostanze tossiche, cose familiari a tutti coloro che hanno letto attentamente le storie su Holmes. Come scrisse Conan Doyle al dottor Bell: “Attorno al nucleo della deduzione, dell’inferenza e dell’osservazione, che ti ho sentito praticare, ho cercato di creare l’immagine di un uomo che è andato il più lontano possibile in queste cose, e talvolta anche oltre." quello conta, dopo di lui: questo detective ha elevato l'arte dell'investigazione al livello di scienza esatta.
La quintessenza dell'approccio inerente a Sherlock Holmes ci viene presentata nella storia "Uno studio in rosso", in cui il detective appare per la prima volta davanti al lettore. Diventa presto chiaro che per Holmes ogni caso non è semplicemente un caso come appare alla polizia di Scotland Yard (un delitto, una serie di fatti, più persone coinvolte, una sintesi di informazioni - tutto questo con lo scopo di portare il criminale alla giustizia), ma allo stesso tempo qualcosa di più, e di meno. Di più, perché in questo caso la questione acquista un significato più ampio e generale, come oggetto di studio e riflessione su larga scala, diventando, se si vuole, un compito scientifico. Le sue linee generali sono inevitabilmente visibili nei compiti precedenti e saranno senza dubbio ripetute in quelli futuri. I principi generali si applicano ad altri punti, a prima vista, non correlati. Meno - perché la questione viene spogliata delle sue componenti emotive e ipotetiche - elementi che offuscano la chiarezza del pensiero - e diventa oggettiva quanto può esserlo una realtà al di fuori della scienza. Risultato: la criminalità è un argomento di ricerca strettamente scientifica, che dovrebbe essere affrontato sulla base di principi metodologici scientifici. E la mente umana è la loro serva.
- Casa editrice "Colibrì", Mosca, 2014
Annotazione
È possibile imparare a pensare in modo chiaro e razionale come Sherlock Holmes, o la sua logica impeccabile e la chiarezza cristallina della mente sono solo un'invenzione dello scrittore?
Sì, Maria Konnikova, famosa psicologa e giornalista americana, ne è convinta. Esaminando episodi tratti dai libri di Conan Doyle alla luce delle moderne neuroscienze e psicologia, rivela, passo dopo passo, in modo semplice e coinvolgente, le strategie mentali che portano a un pensiero lucido e a una profonda comprensione di fenomeni e fatti. Il libro descrive come, seguendo l'esempio del grande detective, con il desiderio e un po' di allenamento possiamo affinare la nostra percezione, sviluppare la logica e la creatività.
Traduzione: Ulyana Saptsina
Maria Konnikova
introduzione
Maria Konnikova
Mente straordinaria: pensare come Sherlock Holmes
...
È divertente, ma il libro di Maria Konnikova, affascinante e talvolta provocatorio, ti fa davvero riflettere su come pensiamo.
Recensione del libro
...
Questo è un libro estremamente utile, basato sulle conquiste della psicologia moderna e pieno di esempi tratti dalla vita moderna. Ti aiuterà a trovare un linguaggio comune con il tuo Holmes interiore e trascorrerà più di un'ora con lui su un'accogliente sedia accanto al caminetto, osservando e traendo conclusioni.
Globo di Boston
...
Il nuovo libro di Maria Konnikova non è affatto “elementare”: è uno studio pertinente e ponderato della mente umana, integrato da esempi tratti dalla vita e dal lavoro professionale di Sherlock Holmes. Lo stesso Holmes sarebbe orgoglioso se diventasse l'autore di un'opera così meravigliosa!
Settimanale degli editori
...
Il nuovo libro brillante e talentuoso di Maria Konnikova non è altro che un libro di testo sul risveglio della coscienza, una guida per sbarazzarsi dei pregiudizi del subconscio, dell'abitudine alla distrazione e della confusione dei nostri pensieri quotidiani. Anche quei lettori che non considerano Holmes il loro idolo troveranno il libro stimolante, coinvolgente e, soprattutto, benefico.
L'indipendente
Dedicato a Jeff
La scelta degli oggetti di attenzione - la capacità di prestare attenzione ad alcuni e trascurarne altri - occupa lo stesso posto nelle manifestazioni interne della vita della scelta delle azioni - in quelle esterne. In entrambi i casi, una persona è responsabile della sua scelta ed è costretta a sopportarne le conseguenze. Come diceva Ortega y Gasset, “dimmi a cosa presti attenzione e ti dirò chi sei”.
W. H. Auden
introduzione
Quando ero piccola, prima di andare a letto, mio padre ci leggeva storie su Sherlock Holmes. Mio fratello, cogliendo l'occasione, si addormentò subito nel suo angolo del divano, ma noi altri pendevamo da ogni parola. Ricordo la grande poltrona di pelle su cui sedeva papà, tenendo un libro davanti a sé con una mano, e ricordo come le fiamme che danzavano nel camino si riflettevano nelle lenti dei suoi occhiali dalla montatura nera. Ricordo come alzava e abbassava la voce, aumentando la tensione prima di ogni colpo di scena e, infine, la soluzione tanto attesa, quando tutto improvvisamente aveva un senso, e io scossi la testa, proprio come il dottor Watson, e pensai: " Beh, certo! Com’è semplice ora che ha spiegato tutto!” Ricordo l'odore della pipa che papà fumava così spesso, il modo in cui il fumo dolce di una miscela di tabacco grezzo si depositava tra le pieghe di una sedia di pelle, ricordo le forme notturne dietro le tende e la porta a vetri. La pipa di papà, ovviamente, era leggermente curva, esattamente come quella di Holmes. Ricordo anche il suono finale del libro che si chiudeva sbattendo, quando le pagine venivano rimesse insieme sotto le copertine cremisi della rilegatura, e papà annunciava: “Per oggi è tutto”. E ci siamo lasciati: era inutile implorare, implorare e fare smorfie pietose - di sopra e a letto.
E allora un altro dettaglio rimase impresso nella mia memoria - così profondamente che vi rimase, senza darmi tregua, anche molti anni dopo, quando il resto delle storie svanì, fondendosi con uno sfondo sfocato e le avventure di Holmes e dei suoi devoti biografo furono dimenticati tutti. Questo dettaglio sono i passaggi.
I gradini del 221B di Baker Street. Quanti erano? Holmes ha chiesto a Watson di questo in A Scandal in Bohemia, e la sua domanda mi è sempre rimasta in testa. Holmes e Watson sono seduti uno accanto all'altro sulle poltrone, il detective spiega al medico come la capacità di guardare semplicemente differisce dalla capacità di notare. Watson è perplesso. E poi all'improvviso tutto diventa completamente chiaro.
...
"Quando ascolto il tuo ragionamento", ha osservato Watson, "tutto mi sembra ridicolmente semplice, al punto che io stesso avrei indovinato senza difficoltà, ma in ogni singolo caso sono perplesso finché non spieghi il corso dei tuoi pensieri . Tuttavia sono convinto che il mio occhio è acuto quanto il tuo.
"Esattamente", rispose Holmes, accendendosi una sigaretta e appoggiandosi allo schienale della sedia. – Vedi, ma non te ne accorgi. La differenza è ovvia. Ad esempio, vedi spesso dei gradini che conducono dal corridoio a questa stanza.
- Spesso.
- Quante volte li hai già visti?
- Diverse centinaia.
- E quanti gradini ci sono?
– Un passo?..non lo so.
- Esattamente! Non te ne sei accorto. Anche se li abbiamo visti. E' di questo che stiamo parlando. E so che lì ci sono diciassette gradini, perché li ho visti e li ho notati”.
Rimasi scioccato da questo dialogo, ascoltato una sera alla luce del camino, quando nell'aria aleggiava il fumo della pipa. Cercavo freneticamente di ricordare quanti gradini c'erano in casa nostra (non ne avevo idea), quanti portavano alla nostra porta d'ingresso (di nuovo nessuna risposta), e quanti conducevano al seminterrato (dieci? Venti? Non ci riuscivo). non fornire nemmeno un numero approssimativo). Per molto tempo ho provato a contare i passi di tutte le scale che incontravo e a ricordare i risultati ottenuti, nel caso qualcuno mi chiedesse un resoconto. Holmes sarebbe fiero di me.
Naturalmente, ho dimenticato quasi immediatamente ogni numero che ho cercato così duramente di ricordare - solo molto più tardi mi sono reso conto che concentrandomi interamente sulla memorizzazione, stavo perdendo di vista la vera essenza del problema. I miei sforzi sono stati vani fin dall’inizio.
All'epoca non avevo realizzato che Holmes avesse un vantaggio significativo su di me. Ha trascorso gran parte della sua vita ad affinare il suo metodo di interazione ponderata con il mondo che lo circonda. E i gradini della casa di Baker Street sono solo un modo per dimostrare un'abilità che usava con naturalezza, senza pensare. Una delle manifestazioni di un processo che abitualmente e quasi inconsciamente avviene nella sua mente sempre attiva. Se preferisci, un trucco che non ha alcuno scopo pratico e allo stesso tempo pieno di significato più profondo, devi solo pensare a cosa lo ha reso possibile. Un trucco che mi ha ispirato a scrivere un intero libro a riguardo.
L’idea di premurosità non è affatto nuova. Indietro alla fine del 19° secolo. il padre della psicologia moderna, William James, scriveva che “la capacità di focalizzare consapevolmente l'attenzione errante, facendolo ancora e ancora, è il primo fondamento del giudizio, del carattere e della volontà... La migliore educazione è quella che sviluppa questa capacità. " L'abilità menzionata stessa è la quintessenza della premurosità. E l'educazione proposta da James insegna un approccio ponderato alla vita e al pensiero.
Negli anni '70 XX secolo Ellen Langer ha dimostrato che la premurosità può fare molto di più che cambiare semplicemente “giudizio, carattere e volontà”. Praticando la consapevolezza, gli anziani si sentono addirittura più giovani e agiscono di conseguenza, un approccio che migliora i loro segni vitali, come la pressione sanguigna, e la funzione cognitiva. Le ricerche degli ultimi anni hanno dimostrato: la meditazione-riflessione (esercizi per il controllo completo dell'attenzione, che costituisce la base della riflessione), se eseguita per soli quindici minuti al giorno, modifica gli indicatori di attività dei lobi frontali del cervello in una direzione più caratteristico di uno stato emotivo positivo e attenzione ai risultati, in altre parole, anche un breve periodo di contemplazione della natura può renderci più perspicaci, creativi e produttivi. Inoltre, ora possiamo affermare con grande certezza: il nostro cervello non è progettato per il multitasking, il che esclude completamente la riflessione. Quando siamo costretti a fare molte cose contemporaneamente, non solo affrontiamo peggio tutti questi compiti: la nostra memoria si deteriora e il nostro benessere generale ne risente notevolmente.
annotazione
È possibile imparare a pensare in modo chiaro e razionale come Sherlock Holmes, o la sua logica impeccabile e la chiarezza cristallina della mente sono solo un'invenzione dello scrittore?
Sì, Maria Konnikova, famosa psicologa e giornalista americana, ne è convinta. Esaminando episodi tratti dai libri di Conan Doyle alla luce delle moderne neuroscienze e psicologia, rivela, passo dopo passo, in modo semplice e coinvolgente, le strategie mentali che portano a un pensiero lucido e a una profonda comprensione di fenomeni e fatti. Il libro descrive come, seguendo l'esempio del grande detective, con il desiderio e un po' di allenamento possiamo affinare la nostra percezione, sviluppare la logica e la creatività.
Maria Konnikova Mente straordinaria: pensa come Sherlock Holmes
È divertente, ma il libro di Maria Konnikova, affascinante e talvolta provocatorio, ti fa davvero riflettere su come pensiamo.
Recensione del libro
Questo è un libro estremamente utile, basato sulle conquiste della psicologia moderna e pieno di esempi tratti dalla vita moderna. Ti aiuterà a trovare un linguaggio comune con il tuo Holmes interiore e trascorrerà più di un'ora con lui su un'accogliente sedia accanto al caminetto, osservando e traendo conclusioni.
Globo di Boston
Il nuovo libro di Maria Konnikova non è affatto “elementare”: è uno studio pertinente e ponderato della mente umana, integrato da esempi tratti dalla vita e dal lavoro professionale di Sherlock Holmes. Lo stesso Holmes sarebbe orgoglioso se diventasse l'autore di un'opera così meravigliosa!
Settimanale degli editori
Il nuovo libro brillante e talentuoso di Maria Konnikova non è altro che un libro di testo sul risveglio della coscienza, una guida per sbarazzarsi dei pregiudizi del subconscio, dell'abitudine alla distrazione e della confusione dei nostri pensieri quotidiani. Anche quei lettori che non considerano Holmes il loro idolo troveranno il libro stimolante, coinvolgente e, soprattutto, benefico.
L'indipendente
Dedicato a Jeff
La scelta degli oggetti di attenzione - la capacità di prestare attenzione ad alcuni e trascurarne altri - occupa lo stesso posto nelle manifestazioni interne della vita della scelta delle azioni - in quelle esterne. In entrambi i casi, una persona è responsabile della sua scelta ed è costretta a sopportarne le conseguenze. Come diceva Ortega y Gasset, “dimmi a cosa presti attenzione e ti dirò chi sei”.
W. H. Auden
introduzione
Quando ero piccola, prima di andare a letto, mio padre ci leggeva storie su Sherlock Holmes. Mio fratello, cogliendo l'occasione, si addormentò subito nel suo angolo del divano, ma noi altri pendevamo da ogni parola. Ricordo la grande poltrona di pelle su cui sedeva papà, tenendo un libro davanti a sé con una mano, e ricordo come le fiamme che danzavano nel camino si riflettevano nelle lenti dei suoi occhiali dalla montatura nera. Ricordo come alzava e abbassava la voce, aumentando la tensione prima di ogni colpo di scena e, infine, la soluzione tanto attesa, quando tutto improvvisamente aveva un senso, e io scossi la testa, proprio come il dottor Watson, e pensai: " Beh, certo! Com’è semplice ora che ha spiegato tutto!” Ricordo l'odore della pipa che papà fumava così spesso, il modo in cui il fumo dolce di una miscela di tabacco grezzo si depositava tra le pieghe di una sedia di pelle, ricordo le forme notturne dietro le tende e la porta a vetri. La pipa di papà, ovviamente, era leggermente curva, esattamente come quella di Holmes. Ricordo anche il suono finale del libro che si chiudeva sbattendo, quando le pagine venivano rimesse insieme sotto le copertine cremisi della rilegatura, e papà annunciava: “Per oggi è tutto”. E ci siamo lasciati: era inutile implorare, implorare e fare smorfie pietose - di sopra e a letto.
E allora un altro dettaglio rimase impresso nella mia memoria - così profondamente che vi rimase, senza darmi tregua, anche molti anni dopo, quando il resto delle storie svanì, fondendosi con uno sfondo sfocato e le avventure di Holmes e dei suoi devoti biografo furono dimenticati tutti. Questo dettaglio sono i passaggi.
I gradini del 221B di Baker Street. Quanti erano? Holmes ha chiesto a Watson di questo in A Scandal in Bohemia, e la sua domanda mi è sempre rimasta in testa. Holmes e Watson sono seduti uno accanto all'altro sulle poltrone, il detective spiega al medico come la capacità di guardare semplicemente differisce dalla capacità di notare. Watson è perplesso. E poi all'improvviso tutto diventa completamente chiaro.
"Quando ascolto il tuo ragionamento", ha osservato Watson, "tutto mi sembra ridicolmente semplice, al punto che io stesso avrei indovinato senza difficoltà, ma in ogni singolo caso sono perplesso finché non spieghi il corso dei tuoi pensieri . Tuttavia sono convinto che il mio occhio è acuto quanto il tuo.
"Esattamente", rispose Holmes, accendendosi una sigaretta e appoggiandosi allo schienale della sedia. – Vedi, ma non te ne accorgi. La differenza è ovvia. Ad esempio, vedi spesso dei gradini che conducono dal corridoio a questa stanza.
- Spesso.
- Quante volte li hai già visti?
- Diverse centinaia.
- E quanti gradini ci sono?
– Un passo?..non lo so.
- Esattamente! Non te ne sei accorto. Anche se li abbiamo visti. E' di questo che stiamo parlando. E so che lì ci sono diciassette gradini, perché li ho visti e li ho notati”.
Rimasi scioccato da questo dialogo, ascoltato una sera alla luce del camino, quando nell'aria aleggiava il fumo della pipa. Cercavo freneticamente di ricordare quanti gradini c'erano in casa nostra (non ne avevo idea), quanti portavano alla nostra porta d'ingresso (di nuovo nessuna risposta), e quanti conducevano al seminterrato (dieci? Venti? Non ci riuscivo). non fornire nemmeno un numero approssimativo). Per molto tempo ho provato a contare i passi di tutte le scale che incontravo e a ricordare i risultati ottenuti, nel caso qualcuno mi chiedesse un resoconto. Holmes sarebbe fiero di me.
Naturalmente, ho dimenticato quasi immediatamente ogni numero che ho cercato così duramente di ricordare - solo molto più tardi mi sono reso conto che concentrandomi interamente sulla memorizzazione, stavo perdendo di vista la vera essenza del problema. I miei sforzi sono stati vani fin dall’inizio.
All'epoca non avevo realizzato che Holmes avesse un vantaggio significativo su di me. Ha trascorso gran parte della sua vita ad affinare il suo metodo di interazione ponderata con il mondo che lo circonda. E i gradini della casa di Baker Street sono solo un modo per dimostrare un'abilità che usava con naturalezza, senza pensare. Una delle manifestazioni di un processo che abitualmente e quasi inconsciamente avviene nella sua mente sempre attiva. Se preferisci, un trucco che non ha alcuno scopo pratico e allo stesso tempo pieno di significato più profondo, devi solo pensare a cosa lo ha reso possibile. Un trucco che mi ha ispirato a scrivere un intero libro a riguardo.
L'idea di premurosità 1 Il termine consapevolezza verrà tradotto di seguito con le parole “premurosità” o “approccio ponderato”; nella letteratura in lingua russa viene tradotto in modo diverso, comprese le parole “consapevolezza” e “coinvolgimento mentale”. – Nota sentiero[Chiudi] non è affatto una novità. Indietro alla fine del 19° secolo. il padre della psicologia moderna, William James, scriveva che “la capacità di focalizzare consapevolmente l'attenzione errante, facendolo ancora e ancora, è il primo fondamento del giudizio, del carattere e della volontà... La migliore educazione è quella che sviluppa questa capacità. " L'abilità menzionata stessa è la quintessenza della premurosità. E l'educazione proposta da James insegna un approccio ponderato alla vita e al pensiero.
Negli anni '70 XX secolo Ellen Langer ha dimostrato che la premurosità può fare molto di più che cambiare semplicemente “giudizio, carattere e volontà”. Praticando la consapevolezza, gli anziani si sentono addirittura più giovani e agiscono di conseguenza, un approccio che migliora i loro segni vitali, come la pressione sanguigna, e la funzione cognitiva. Le ricerche degli ultimi anni hanno dimostrato: la meditazione-riflessione (esercizi per il controllo completo dell'attenzione, che costituisce la base della riflessione), se eseguita per soli quindici minuti al giorno, modifica gli indicatori di attività dei lobi frontali del cervello in una direzione più caratteristico di uno stato emotivo positivo e attenzione ai risultati, in altre parole, anche un breve periodo di contemplazione della natura può renderci più perspicaci, creativi e produttivi. Inoltre, ora possiamo affermare con grande certezza: il nostro cervello non è progettato per il multitasking, il che esclude completamente la riflessione. Quando siamo costretti a fare molte cose contemporaneamente, non solo affrontiamo peggio tutti questi compiti: la nostra memoria si deteriora e il nostro benessere generale ne risente notevolmente.
Ma per Sherlock Holmes la presenza premurosa è solo il primo passo. Suggerisce uno scopo molto più significativo, utilitaristico e gratificante. Holmes raccomanda ciò che William James raccomandava: imparare a sviluppare le nostre capacità di pensiero riflessivo e metterle in pratica in modo da poter ottenere di più, pensare meglio e prendere decisioni migliori più spesso. In altre parole, si tratta di migliorare la nostra capacità di prendere decisioni e costruire inferenze, a partire dalle fondamenta, dagli elementi costitutivi che compongono la nostra mente.
Contrastando la capacità di vedere con la capacità di notare, Holmes spiega infatti a Watson che in nessun caso si dovrebbe confondere la spensieratezza con la premurosità, o confondere un approccio passivo con un coinvolgimento attivo. La nostra vista funziona in modo automatico: questo flusso di informazioni sensoriali non richiede alcuno sforzo da parte nostra, dobbiamo solo tenere gli occhi aperti. E vediamo senza pensare, assorbiamo innumerevoli elementi del mondo circostante, senza degnare ciò che vediamo con la necessaria elaborazione da parte del cervello. A volte non siamo nemmeno consapevoli di ciò che è davanti ai nostri occhi. Per notare qualcosa, devi concentrare la tua attenzione. Per fare ciò è necessario passare dall'assorbimento passivo delle informazioni alla loro percezione attiva. Cioè, lasciati coinvolgere consapevolmente in esso. Ciò vale non solo per la vista, ma per tutti i sensi, per tutte le informazioni in arrivo e per ogni pensiero.
Troppo spesso trattiamo la nostra mente con sorprendente sconsideratezza. Seguiamo il flusso, inconsapevoli di quanto ci manca nel nostro processo di pensiero, e non abbiamo idea di quanto trarremmo beneficio dal prenderci del tempo per capirlo e dargli un senso. Come Watson, percorriamo le stesse scale decine, centinaia, migliaia di volte, più volte al giorno, ma non cerchiamo di ricordare nemmeno le caratteristiche più semplici di questa scala (non mi sorprenderei se Holmes non chiedesse della numero di passi, ma del loro colore e scopro che anche questo dettaglio è passato inosservato a Watson).
Non è che siamo incapaci di ricordare: è solo che noi stessi preferiamo non farlo. Ricorda la tua infanzia. Se ti chiedessi di parlare della strada in cui sei cresciuto, è probabile che ricorderesti moltissimi dettagli: il colore delle case, le stranezze dei vicini. Odori in diversi periodi dell'anno. Come appariva la strada nelle diverse ore del giorno. Luoghi dove hai giocato e dove sei passato. E dove si guardavano bene dall'andare. Ti garantisco che la storia durerebbe per ore.
Da bambini siamo estremamente sensibili. Assorbiamo ed elaboriamo le informazioni a una velocità che non possiamo nemmeno sognare in futuro. Nuovi panorami, nuovi suoni e odori, nuove persone, emozioni, impressioni: impariamo a conoscere il nostro mondo e le sue possibilità. Tutto intorno è nuovo, tutto è interessante, tutto suscita curiosità. È proprio per questa novità di tutto ciò che ci circonda che siamo sensibili e vigili, siamo concentrati e non ci lasciamo sfuggire nulla. Inoltre, grazie alla motivazione e al coinvolgimento (due qualità su cui torneremo più di una volta), non solo percepiamo il mondo in modo più completo di quanto faremo in seguito, ma immagazziniamo anche informazioni per un uso futuro. Chissà cosa potrebbe tornare utile e quando?
Man mano che invecchiamo, la nostra sazietà cresce in modo esponenziale. Ci siamo già passati, abbiamo già affrontato tutto questo, non c'è bisogno di prestarci attenzione e ne avrò mai bisogno? Prima che ce ne rendiamo conto, perdiamo la nostra naturale attenzione, passione e curiosità e soccombiamo all’abitudine alla passività e alla sconsideratezza. E anche quando vogliamo lasciarci trasportare da qualcosa, si scopre che questo lusso, così accessibile durante l'infanzia, ci è già stato negato. Sono finiti i giorni in cui il nostro compito principale era imparare, assorbire, interagire; Ora abbiamo altre responsabilità, più rilevanti (come ci sembra), la nostra mente deve servire altri bisogni. E man mano che la richiesta della nostra attenzione aumenta – il che è allarmante nell’era digitale, quando al cervello è richiesto di risolvere molteplici compiti paralleli ventiquattro ore al giorno, sette giorni alla settimana – la nostra attenzione in realtà diminuisce. Così facendo, perdiamo gradualmente la capacità di riflettere o di notare le nostre abitudini mentali e permettiamo sempre più alla nostra mente di dettare i nostri giudizi e decisioni piuttosto che fare il contrario. Non c’è niente di sbagliato in questo fenomeno in sé – menzioneremo la necessità di automatizzare alcuni processi inizialmente difficili e cognitivamente costosi – ma ci avvicina pericolosamente all’insensatezza. Il confine tra destrezza e meccanicità sconsiderata è sottile, e qui bisogna stare estremamente attenti per non oltrepassarlo accidentalmente.
Probabilmente hai riscontrato situazioni in cui devi rinunciare a muoverti su una pista zigrinata e all'improvviso si scopre che hai dimenticato come farlo. Diciamo che tornando a casa devi fermarti in farmacia. Ti sei ricordato di questo compito imminente tutto il giorno. Hai provato nella tua mente, immaginando dove girare di nuovo per arrivare dove devi andare, deviando solo leggermente dal tuo solito percorso. E ora ti ritrovi vicino alla casa, senza nemmeno ricordare che saresti andato da qualche altra parte. Ti sei dimenticato di fare una svolta in più, sei passato oltre e non ti è passato per la testa il minimo pensiero. È intervenuta l'insensatezza nata dall'abitudine, e la routine ha sopraffatto la parte del cervello che sapeva che avevi in programma un'altra cosa.
Questo succede continuamente. Siamo così presi dalla routine che trascorriamo metà della giornata in uno stupore insensato. (Stai ancora pensando al lavoro? Preoccupato per un'e-mail? Pianificare la cena in anticipo? Lascia perdere!) Questa dimenticanza automatica, questo potere della routine, questa facilità con cui siamo pronti a distrarci è ancora una sciocchezza, anche se evidente (visto che siamo data l’opportunità di renderci conto che ci siamo dimenticati di fare qualcosa), questa piccola cosa è solo una piccola parte di un fenomeno molto più ampio. Quanto sopra accade più spesso di quanto pensiamo: raramente ci rendiamo conto della nostra sconsideratezza. Quanti pensieri nascono nella nostra mente e si dissipano prima che riusciamo a coglierli? Quante idee e intuizioni ci sfuggono perché dimentichiamo di prestare loro attenzione? Quante decisioni prendiamo senza renderci conto di come o perché le abbiamo prese, guidati da alcune impostazioni interne “predefinite” – impostazioni di cui siamo vagamente consapevoli o non sospettiamo affatto? Quante volte ci capita di avere giorni in cui improvvisamente riprendiamo i sensi e ci chiediamo cosa abbiamo fatto e come siamo arrivati a questo punto della vita?
Lo scopo di questo libro è aiutarti. Usando i principi di Holmes come esempio, esamina e spiega i passi che devi compiere per sviluppare l'abitudine di un contatto premuroso con te stesso e il mondo che ti circonda. Così che anche tu possa menzionare con disinvoltura il numero esatto di gradini della scala, tra lo stupore di un interlocutore meno attento.
Quindi, accendi il fuoco, rannicchiati sul divano e preparati a prendere parte ancora una volta alle avventure di Sherlock Holmes e del dottor Watson nelle strade infestate dalla criminalità di Londra e nei recessi più profondi della mente umana.
- 37.