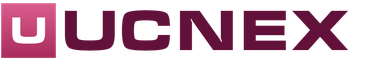La principale questione ideologica dell'adolescenza. Capitolo VIII
Un'acquisizione caratteristica della prima giovinezza è la formazione di progetti di vita. Un progetto di vita come insieme di intenzioni diventa gradualmente un programma di vita, quando oggetto di riflessione non è solo il risultato finale, ma anche le modalità per raggiungerlo. Un progetto di vita è un piano di azioni potenzialmente possibili. Nel contenuto dei piani, come osservato da I.S. Contro, ci sono una serie di contraddizioni. Nelle loro aspettative legate alle future attività professionali e familiari, i ragazzi e le ragazze sono piuttosto realistici. Ma nelle sfere dell’istruzione, del progresso sociale e del benessere materiale, le loro pretese sono spesso esagerate. Allo stesso tempo, l’elevato livello di aspirazioni non è supportato da un altrettanto elevato livello di aspirazioni professionali. Per molti giovani il desiderio di guadagnare di più non è combinato con la disponibilità psicologica a lavori più intensivi e qualificati. I progetti professionali dei ragazzi e delle ragazze non sono sufficientemente corretti. Pur valutando realisticamente la sequenza dei loro futuri successi nella vita, sono eccessivamente ottimisti nel determinare i possibili tempi della loro attuazione. Allo stesso tempo, le ragazze si aspettano risultati in tutti gli ambiti della vita in età più precoce rispetto ai ragazzi. Ciò dimostra la loro mancanza di preparazione per le difficoltà e i problemi reali di una futura vita indipendente. La principale contraddizione nelle prospettive di vita dei giovani uomini e donne è la loro mancanza di indipendenza e disponibilità all'impegno per la futura realizzazione dei loro obiettivi di vita. Gli obiettivi che i futuri laureati si prefiggono, pur rimanendo non testati per quanto riguarda la conformità con le loro reali capacità, spesso si rivelano falsi e soffrono di “fantasyismo”. A volte, avendo appena provato qualcosa, i giovani provano delusione sia nei loro piani che in se stessi. La prospettiva delineata può essere molto specifica e quindi non sufficientemente flessibile affinché la sua implementazione abbia successo; o troppo generali e ostacolano il successo dell’attuazione a causa dell’incertezza.
Disponibilità all'autodeterminazione come principale nuova formazione della prima adolescenza
Uno dei risultati di questa fase è un nuovo livello di sviluppo dell'autoconsapevolezza.
· scoperta del proprio mondo interiore in tutta la sua integrità e unicità individuale.
· desiderio di conoscenza di sé.
· formazione dell'identità personale, senso di identità personale, continuità e unità.
· rispetto per sè stessi
· la formazione di un modo di essere personale, quando in molti scontri della vita un giovane può dire ad alta voce: "Ne sono personalmente responsabile!"
Situazione sociale dello sviluppo in adolescenza
Cambiamenti nella posizione interna dell'individuo durante il passaggio dall'adolescenza all'adolescenza (attenzione al futuro). La nuova natura dei bisogni dei giovani è mediata, consapevole e volontaria. I bisogni fondamentali dell'adolescenza: comunicazione con i coetanei, indipendenza, affetto, successo (motivo del successo), autorealizzazione e sviluppo del proprio sé, padronanza di nuovi ruoli sociali durante l'adolescenza. Compiti dell'adolescenza: scegliere una professione e prepararsi al lavoro, prepararsi al matrimonio e creare la propria famiglia. L'attività educativa e professionale come attività trainante dell'adolescenza.
Formazione della visione del mondo
L'autodeterminazione sociale e la ricerca di se stessi sono indissolubilmente legate alla formazione di una visione del mondo.
La giovinezza è una fase decisiva nella formazione di una visione del mondo, perché è in questo momento che maturano sia i suoi prerequisiti cognitivi che quelli emotivi e personali. L'adolescenza è caratterizzata non solo da un aumento del volume delle conoscenze, ma anche da un'enorme espansione degli orizzonti mentali di uno studente delle scuole superiori, dall'emergere di interessi teorici e dalla necessità di ridurre la varietà dei fatti a pochi principi. Sebbene il livello specifico di conoscenza, abilità teoriche e ampiezza di interessi tra i ragazzi siano molto diversi, tra tutti si osservano alcuni cambiamenti in questa direzione, dando un potente impulso al “filosofare” giovanile.
La visione del mondo è una visione del mondo nel suo insieme, un sistema di idee sui principi generali e sui fondamenti dell'esistenza, la filosofia di vita di una persona, la somma e il risultato di tutta la sua conoscenza. I prerequisiti cognitivi (cognitivi) per una visione del mondo sono l'assimilazione di una certa e molto significativa quantità di conoscenza (non può esserci una visione del mondo scientifica senza padronanza della scienza) e la capacità dell'individuo di pensare teorico astratto, senza il quale le disparate conoscenze specializzate non formano un sistema unico.
Ma una visione del mondo non è tanto un sistema logico di conoscenza quanto un sistema di credenze che esprimono l'atteggiamento di una persona nei confronti del mondo, i suoi principali orientamenti di valore.
Per comprendere il problema dell'autodeterminazione personale, va notato un punto estremamente significativo: il livello della personalità è il livello di determinazione semantica del valore, il livello di esistenza nel mondo dei significati e dei valori. Come sottolineano B.V. Zeigarnik e B.S. Bratus, per l’individuo “il piano principale del movimento è morale e basato sui valori. Il primo punto è che l'esistenza dei significati nel mondo è un'esistenza a livello effettivamente personale (lo ha sottolineato L.S. Vygotskij); l'area dei significati e dei valori è l'area in cui avviene l'interazione tra l'individuo e la società; valori e significati sono, in senso stretto, il linguaggio di questa interazione. Il secondo punto è il ruolo guida dei valori per la formazione della personalità: la confessione dei valori consolida l'unità e l'identità personale dell'individuo, determinando a lungo le principali caratteristiche della personalità, il suo nucleo, la sua moralità , la sua etica. Il valore viene acquisito dall'individuo, poiché “... non c'è altro modo di affrontare il valore se non la sua esperienza olistica e personale. Pertanto, l'acquisizione di valore è l'acquisizione di se stessa da parte di una persona. E il terzo - assegnato B.V. Zeigarnik e B.S. Funzioni di Bratusem dell'educazione semantica: creare uno standard, un'immagine del futuro e valutare l'attività dal suo lato morale e semantico.
Accentuazioni e scelta della professione
Lo sviluppo della personalità e la formazione di una visione del mondo è un processo molto complesso e contraddittorio, soggetto a molte influenze diverse. Il problema degli orientamenti di valore...
Biografia di Sigmund Freud
Nell'autunno del 1873 Sigmund Freud, all'età di diciassette anni, entrò nella facoltà di medicina dell'Università di Vienna...
L'influenza della visione del mondo a livello delle aspirazioni individuali
Caratteristiche di genere della visione del mondo anticriminale degli studenti in classi specializzate
Quindi, al nostro sondaggio hanno preso parte studenti di 10 classi: 1. Classe di discipline umanistiche (“A”) 11 ragazze e 5 ragazzi hanno compilato i questionari. 2. Classe di direzione tecnica (“B”) I questionari sono stati compilati da 10 ragazze e 10 ragazzi...
Età matura
Lo sviluppo professionale è inteso come un processo personale individuale, il cui elemento principale è la scelta personale. Il fondatore dell'approccio scientifico e psicologico al problema dello sviluppo professionale della personalità F...
Storia dello sviluppo e dell'istituzione della psicodiagnostica in Russia
La storia della psicodiagnostica moderna inizia con il primo quarto del XIX secolo, cioè con l'inizio del cosiddetto periodo clinico nello sviluppo della conoscenza psicologica. Questo periodo è caratterizzato da...
Visioni del mondo di persone con stili alimentari diversi
In molte culture del mondo, il termine “visione del mondo” ha un significato linguistico comune, essendo composto da due parole “mondo” e “visione” o “sguardo”. In tedesco si dice "weltanschaunung"...
Visioni del mondo di persone con stili alimentari diversi
Considerando il concetto di "visione del mondo" in un contesto scientifico e psicologico, si possono considerare concetti correlati, generici, al fine di comprendere in modo più accurato e definitivo il significato del primo. Quindi sì. Leontyev ritiene che il concetto di “immagine del mondo”...
Peculiarità della sfera emotiva della personalità dei cybersportivi
Esplosioni, proiettili volanti di un lanciarazzi, tesi da un lato all'altro come linee elettriche ad alta tensione, archi di una pistola a raggi, fulmini accecanti e tuoni dietro di loro quando la pistola elettrica è in azione. Questa non è la terza guerra mondiale...
Meccanismi mentali della formazione di una visione religiosa del mondo nella psicoanalisi classica
Come già notato, le opere di S. Freud sono di fondamentale importanza dal punto di vista della comprensione dell'emergere della religione. In questo capitolo cercheremo di rivedere e sistematizzare i pensieri di Z...
La conquista da parte dei mezzi di comunicazione di massa di un pubblico sempre più vasto di fonti di informazione rappresenta uno dei risultati pratici più importanti dell’attività informativa e ideologica dello Stato...
La connessione tra l'accentuazione del carattere e la scelta della futura professione da parte degli scolari più grandi
Lo sviluppo della personalità e la formazione di una visione del mondo è un processo molto complesso e contraddittorio, soggetto a molte influenze diverse. Il problema degli orientamenti di valore...
Concetto di sé ed educazione
Ananyev identifica le fasi principali della formazione dell'autocoscienza in relazione allo sviluppo di azioni e comunicazioni oggettive. Nella fase 1, il bambino separa le sue azioni dagli oggetti delle sue azioni. Ciò accade alla fine del 1° anno di vita...
1. Teorie dello sviluppo morale.
La teoria esistente più frequentemente menzionata in letteratura è La teoria dello sviluppo morale di Lawrence Kohlberg. Questa teoria non è ideale, ma si distingue per la massima elaborazione e armonia. In molti modi, si basa sull’esperienza di vita personale dell’autore e sulla teoria della formazione della moralità di Piaget. Secondo Kohlberg, lo sviluppo morale umano avviene in tre fasi:
1) LIVELLO PRECONVENZIONALE (età prescolare e scuola media) In questa fase le azioni sono dettate dalla paura della punizione o dal desiderio di ricevere una ricompensa.
2) LIVELLO CONVENZIONALE (dopo 12 anni)
Le azioni di una persona sono determinate da ciò che è richiesto dalla legge o dalle regole di vita non scritte (opinione pubblica)
3) POSTCONVENZIONALE (dopo i 18 anni)
Una persona fa la sua scelta in base alle sue convinzioni interiori, che potrebbero non coincidere con l'opinione pubblica o la legge, anche se il prezzo di questa scelta è molto alto.
Il passaggio da una fase all’altra è complesso e contraddittorio. La formazione di una personalità morale dipende dal livello di sviluppo mentale di una persona (la capacità di percepire, applicare e valutare norme e azioni appropriate) dallo sviluppo emotivo, ad es. capacità di empatia e anche dall'esperienza personale e, ovviamente, dall'ambiente sociale (ambiente)
2. Sviluppo morale dell'individuo nella prima giovinezza.
La prima giovinezza è caratterizzata da uno sguardo rivolto al futuro. In questo periodo di tempo relativamente breve, è necessario creare un progetto di vita - per risolvere la questione di chi essere (autodeterminazione professionale) e cosa essere (personale o morale autodeterminazione). Uno studente delle scuole superiori non dovrebbe solo immaginare il suo futuro in termini generali, ma essere consapevole dei modi per raggiungere i suoi obiettivi di vita. L'autodeterminazione, sia professionale che personale, diventa la nuova formazione centrale della prima adolescenza. Questa è una nuova posizione interna, inclusa la consapevolezza di se stessi come membro della società, l'accettazione del proprio posto in essa.
Alla ricerca del significato della vita, del tuo posto in questo mondo può diventare particolarmente teso: i valori dei genitori vengono spesso respinti, ma i figli invece non sono in grado di offrire nulla di proprio. Dopo essersi fusi nella vita adulta, continuano a correre e rimangono irrequieti per molto tempo. Ma non tutti i bambini trovano questo periodo stressante. Al contrario, alcuni studenti delle scuole superiori si muovono dolcemente e gradualmente verso un punto di svolta nella loro vita, per poi essere inclusi con relativa facilità in un nuovo sistema di relazioni, sono più interessati ai valori generalmente accettati, sono più orientati alla valutazione degli altri e fare affidamento sull'autorità. In generale si ritiene che Il pieno sviluppo della personalità è guidato dalle ricerche e dai dubbi caratteristici dell'adolescenza. Coloro che li hanno vissuti sono solitamente più indipendenti, creativi e hanno un pensiero più flessibile che consente loro di prendere decisioni indipendenti in situazioni difficili, rispetto a coloro per i quali il processo di formazione della personalità era facile in quel momento. Con tutto il loro desiderio di indipendenza, i bambini hanno bisogno di esperienza di vita e dell'aiuto degli anziani. Dopotutto, uno studente delle scuole superiori tratta un adulto vicino come un ideale. Apprezza qualità diverse in persone diverse, fungono da standard per lui in diverse aree: nel campo delle relazioni umane, degli standard morali, in diversi tipi di attività. A loro sembra che stia provando il suo "io" ideale - ciò che vuole diventare e sarà in età adulta. Le opinioni e i valori che ricevono dagli adulti vengono poi filtrati e possono essere selezionati e testati nelle interazioni con i pari.
introduzione
visione del mondo della personalità giovanile, autoconsapevolezza
La psicologia dell'adolescenza è una delle sezioni più complesse e meno sviluppate della psicologia dello sviluppo.
La giovinezza è il periodo di completamento della maturazione fisica di una persona, la rapida crescita della sua autocoscienza, la formazione di una visione del mondo, la scelta della professione e l'inizio dell'ingresso nell'età adulta.
Lo scopo del mio lavoro è evidenziare aspetti della psicologia giovanile come: sviluppo mentale e formazione della personalità, sviluppo della coscienza morale, sviluppo psicosessuale e relazioni di genere.
Quando si studia questo argomento, sorgono una serie di domande:
Come si forma l'individualità e la sua consapevolezza?
Quali componenti compongono l’immagine di sé dei giovani?
Cosa guida i giovani nella scelta di una professione?
Qual è il processo di separazione dalla famiglia?
Con quali criteri i giovani scelgono i loro amici?
Come avviene il processo della pubertà?
La rilevanza del problema si manifesta nel fatto che la pubertà è un processo centrale e fondamentale dell'adolescenza, che non può essere ridotto solo ai cambiamenti biologici. La pubertà pone nuovamente in risalto per l'adolescente la questione della sua identità sessuale, in quanto i criteri di “mascolinità” e “femminilità” diventano più complessi, in cui gli stessi aspetti sessuali (la comparsa di caratteristiche sessuali secondarie, interessi sessuali, ecc.) diventano sempre più importanti. importante. Nell'adolescenza, tutti questi problemi sono intrecciati. Uno studente delle scuole superiori conserva ancora la ristrettezza adolescenziale e le prescrizioni di ruolo stereotipate, cercando di dimostrare a se stesso e agli altri che "soddisfa" questi requisiti. Allo stesso tempo, sente già che la sua individualità non rientra nel quadro rigido di questa dicotomia, che le qualità maschili e femminili non sono necessariamente alternative e che la loro combinazione può essere diversa.
Gli obiettivi della ricerca:
studiare approcci teorici e problemi metodologici della psicologia dello sviluppo nello studio dell'adolescenza;
considerare le serie fisiche e sociali dello sviluppo nell'adolescenza, le caratteristiche del loro corso e i fattori che le influenzano;
analizzare le caratteristiche dello sviluppo psicosessuale nei giovani.
La base teorica di questo lavoro erano le opere degli psicologi nazionali e stranieri I.S. Kona, O.V. Kukhlaeva e G. Craig. Durante la stesura del lavoro sono stati utilizzati sussidi didattici e libri di testo di psicologia, sociologia, antropologia e psicologia dello sviluppo.
1. Caratteristiche generali dell'adolescenza come fase dello sviluppo
L’adolescenza separa l’infanzia dall’età adulta. Questo periodo è solitamente suddiviso nella prima adolescenza, cioè età della scuola superiore (dai 15 ai 18 anni) e tarda adolescenza (dai 18 ai 23 anni). In questo periodo, la formazione delle funzioni biologiche e psicologiche di base necessarie affinché un adulto esista pienamente è stata effettivamente completata. Questo è ciò che ha dato origine a molti ricercatori all'inizio e alla metà del XX secolo. affermare che lo sviluppo della personalità termina nell’adolescenza. Vari studi acmeologici condotti negli ultimi decenni hanno dimostrato che lo sviluppo umano continua per tutta la vita. Tuttavia, ciò non riduce l’importanza dell’adolescenza come ultimo periodo preparatorio per entrare nella fase più produttiva e duratura della vita di una persona: l’età adulta.
Lo status sociale dei giovani è eterogeneo. La giovinezza è la fase finale della socializzazione primaria. La stragrande maggioranza dei ragazzi e delle ragazze sono ancora studenti; la loro partecipazione al lavoro produttivo è spesso considerata non solo e non tanto dal punto di vista della sua efficienza economica, ma da un punto di vista educativo. I giovani lavoratori di età compresa tra 16 e 18 anni hanno uno status giuridico speciale e godono di una serie di vantaggi (orario di lavoro ridotto, retribuzione a orario pieno, divieto di lavoro straordinario e notturno e di lavoro nei fine settimana, ferie della durata di un mese solare, ecc.). Allo stesso tempo, l'attività e la struttura del ruolo dell'individuo in questa fase acquisiscono già una serie di nuove qualità adulte. Il principale compito sociale dei giovani è scegliere una professione. L'istruzione generale è completata dall'istruzione speciale e professionale. La scelta della professione e della tipologia dell'istituto scolastico differenzia inevitabilmente i percorsi di vita dei ragazzi e delle ragazze con tutte le conseguenze socio-psicologiche che ne conseguono. La gamma dei ruoli socio-politici e degli interessi e delle responsabilità associati si sta espandendo. Un compito importante a questa età è anche la preparazione per creare una famiglia.
Lo stato sociale intermittente e lo stato giovanile determinano anche alcune caratteristiche mentali. I giovani sono fortemente preoccupati per problemi quali la specificità della propria età, il diritto all’autonomia dagli anziani, ecc. L’autodeterminazione sociale e personale presuppone non tanto l’autonomia dagli adulti, ma un chiaro orientamento e determinazione del proprio posto nel mondo adulto. Insieme alla differenziazione delle capacità e degli interessi mentali, senza i quali è difficile scegliere una professione, ciò richiede lo sviluppo di meccanismi integrativi di autocoscienza, lo sviluppo di una visione del mondo e di una posizione di vita.
La pubertà è il processo centrale e fondamentale dell’adolescenza. Ma questo processo non si riduce alla somma dei cambiamenti biologici. La sessualità umana è un fenomeno biosociale complesso, il prodotto dell’azione combinata di forze biologiche e sociali. Per diventare un uomo o una donna, un individuo deve riconoscere la propria identità di genere e interiorizzare il ruolo di genere appropriato. L’identità di genere di una persona presuppone la consapevolezza da parte dell’individuo del proprio genere, l’acquisizione di competenze e stili di comportamento adeguati, nonché atteggiamenti e orientamenti psicosessuali. Sebbene i modelli di sviluppo della personalità psicosessuale non siano stati sufficientemente studiati, gli psicologi non hanno dubbi sul fatto che l'identificazione sessuale sia un prodotto della socializzazione, dell'educazione e dell'insegnamento. All'età di un anno e mezzo, il bambino di solito sa se è maschio o femmina, anche se non sa come spiegare questa attribuzione. Un bambino di 3-4 anni conosce non solo il proprio genere, ma sa anche distinguere il genere delle persone che lo circondano. Il concetto di genere come proprietà irreversibile si sviluppa nel bambino intorno ai 6-7 anni di età, quando inizia un rapido processo di differenziazione sessuale di attività, atteggiamenti e valori, il cui soggetto è il bambino stesso, e non il bambino stesso. genitori. L’uguaglianza sociale tra uomini e donne che ricevono la stessa istruzione e svolgono le stesse attività indebolisce inevitabilmente la polarizzazione dei ruoli maschili e femminili, soprattutto perché le differenze individuali di uomini e donne non sono mai rientrate nel quadro di questa polarizzazione, il che non significa la completa eliminazione delle differenze di genere nel comportamento e nella psiche. Ma le relazioni tra uomini e donne vengono sempre più costruite non secondo le prescrizioni stereotipate dei ruoli di genere, ma sulla base della presa in considerazione delle caratteristiche individuali dell'individuo. Ciò vale anche per il comportamento sessuale. Il cosiddetto “doppio standard” affermava una morale sessuale diversa per uomini e donne: un uomo può essere sessualmente attivo, una donna deve aspettare pazientemente di essere scelta, e anche allora esercitare moderazione. Oggi tali idee non sono più completamente dominanti; i giovani sono sempre più attenti al principio di uguaglianza di diritti e responsabilità.
Gli adolescenti/giovani sono veri e propri schiavi della “norma”. Sono convinti che debbano esserci regole universali per tutte le situazioni della vita e hanno molta paura di rimanere in qualche modo indietro rispetto ai loro coetanei.
Lo studio della sessualità adolescenziale ha tre argomenti principali:
comportamento sessuale, ad es. azioni in cui si manifesta e si realizza il desiderio sessuale (quando inizia l'attività sessuale, quali sono le fasi del suo sviluppo, la sua intensità, ecc.);
atteggiamenti e orientamenti psicosessuali, ad es. l'atteggiamento delle persone nei confronti delle questioni di genere, della moralità sessuale; questi atteggiamenti differiscono nel grado di consapevolezza ed esistono sia a livello di cultura (atteggiamenti e norme sociali) sia a livello di coscienza individuale;
fantasie ed esperienze erotiche, che sono spesso inconsce e sono studiate principalmente con metodi clinici.
Insegnanti e genitori sono estremamente interessati alle norme di comportamento sessuale legate all'età: quando un bambino inizia a interessarsi alle questioni di genere, a che età un adolescente si innamora per la prima volta, quando un giovane ha il suo primo rapporto sessuale, ecc. Non c’è e non può esserci una risposta generale a queste domande. A parte le variazioni individuali e il fatto che lo stesso evento (ad esempio un bacio) può avere significati psicologici completamente diversi in età diverse, le norme statistiche del comportamento sessuale sono variabili e disuguali nei diversi ambienti.
Il dualismo tra "amore" e "sesso" si manifesta in modo particolarmente netto tra i ragazzi. Da un lato, il sogno giovanile d'amore e l'immagine dell'amato ideale sono estremamente desessualizzati. Quando gli adolescenti chiamano il loro attaccamento emergente “amicizia”, non sono ipocriti; Sentono davvero, prima di tutto, il bisogno di comunicazione e di calore emotivo. Per un ragazzo, il prototipo della sua prima amata è inconsciamente sua madre, e il pensiero dell'intimità sessuale con lei equivale per lui a un sacrilegio. D'altro canto, l'adolescente è in preda ad un forte erotismo diffuso, e l'immagine su cui si proiettano queste fantasie rappresenta spesso soltanto un “oggetto sessuale”, privo di ogni altra caratteristica. A volte (a 13-14 anni) si tratta di un'immagine di gruppo, reale o immaginaria, comune a un intero gruppo di ragazzi. Discorsi sporchi, battute sporche, immagini pornografiche suscitano un crescente interesse in molti adolescenti, permettendo loro di “radicare” e “ridurre” le esperienze erotiche che li eccitano, per le quali non sono psicologicamente e culturalmente preparati.
Una caratteristica importante della sessualità degli adolescenti e dei giovani adulti è la sua natura “sperimentale”. Scoprendo le sue capacità sessuali, un adolescente le esplora da diverse angolazioni. In nessun'altra età si registra un numero così elevato di casi di comportamento sessuale deviante, vicino al patologico, come a 12-15 anni. Gli adulti richiedono grande conoscenza e tatto per distinguere i sintomi veramente allarmanti da forme di "sperimentazione" sessuale esteriormente simili a loro e, tuttavia, del tutto naturali per questa età, su cui non bisogna concentrarsi, per non danneggiare accidentalmente la loro salute. trauma mentale dell'adolescente, instillando in lui l'idea che "qualcosa non va" in lui. Se non c'è fiducia che un adulto comprenda veramente l'essenza della questione e possa aiutare, deve essere rigorosamente guidato dal primo comandamento del vecchio codice medico: "Non fare del male!"
Quanto più bassa è l'età dei giovani al primo rapporto sessuale, tanto meno moralmente motivato è di regola questo rapporto e meno amore c'è in esso.
La questione della natura psicologica dell'amore e della sua relazione con altri attaccamenti non sessuali è stata a lungo controversa. Nella scienza moderna ci sono due punti di vista su questo argomento.
Il primo si riduce al fatto che l'insieme dei sentimenti e delle esperienze che le persone chiamano amore non sono altro che una sovrastruttura psicologica sul desiderio sessuale, che è di natura biologica. Questo punto di vista è stato difeso in modo più coerente da 3. Freud, il quale credeva che tutti gli attaccamenti umani derivassero da una fonte comune: il desiderio sessuale, la "libido". Il nucleo di ciò che chiamiamo amore, ha scritto nel libro “Psicologia di massa e autoanalisi”, è l’amore sessuale, il cui obiettivo è l’intimità sessuale. La forza della posizione di Freud sta nel tentativo di unire insieme le pulsioni “spirituali” e “corporee”, che in tutte le teorie idealistiche, a cominciare da Platone, sono separate. Tuttavia, avendo compreso correttamente che la vita sessuale di una persona non è qualcosa di isolato, che è indissolubilmente legata a tutta la sua personalità, Freud, senza prove, la dichiarò la base della vita mentale.
Nella scienza moderna, la posizione di Freud è soggetta a serie critiche. I sessuologi non sono soddisfatti del concetto stesso di “istinto sessuale”, “desiderio” o “libido”. Nessuno, ovviamente, nega che una persona abbia determinati bisogni sessuali. Ma il “desiderio sessuale” non è semplice. Ogni individuo ha una sorta di potenziale sessuale naturale, ma il "copione" del suo comportamento sessuale, chi e come amerà, è determinato dall'intero insieme di condizioni che hanno formato la sua personalità. È stato criticato anche il “pansessualismo” freudiano. Se la teoria di Freud sull'origine "sessuale" di tutti gli attaccamenti affettivi è corretta, dovrebbe applicarsi anche agli animali. E poiché gli animali non hanno bisogno di “reprimere” o “sublimare” i propri istinti, il loro attaccamento reciproco deve essere esplicitamente sessuale (almeno in certi momenti). Ma sebbene gli psicologi animali abbiano assistito a molti casi di attaccamenti individuali forti ed altamente emotivi tra animali, a volte anche di specie diverse, questi attaccamenti non sono motivati sessualmente. L'“altruismo” e l'attrazione per l'intimità emotiva con un altro essere vivente non sono, a quanto pare, una “estensione” o una “deviazione” dell'istinto sessuale, ma l'espressione di un altro bisogno indipendente, non meno profondo. Proprio come è impossibile classificare forme di attività umana in cui la comunicazione sarebbe assente, così in ogni classificazione dei bisogni o delle pulsioni “fondamentali” c’è posto per il bisogno di “contatto emotivo”, di “appartenenza” e di “amore”. " È questo bisogno, ereditato dall'uomo dai suoi antenati animali, che costituisce probabilmente il fondamento istintivo-biologico della sua socievolezza, che, tuttavia, non si sviluppa in un bambino spontaneamente, ma nel processo e sotto l'influenza della sua comunicazione con le persone intorno a lui.
Sebbene la sessualità influenzi la natura dei legami interpersonali, non è la loro unica base affettiva e anche le sue stesse manifestazioni dipendono da condizioni sociali specifiche. COME. Makarenko ha scritto che l’amore umano “non può essere coltivato semplicemente dal profondo di un semplice desiderio sessuale zoologico. I poteri dell'amore possono essere trovati solo nell'esperienza della simpatia umana non sessuale. Un giovane non amerà mai la sua sposa e sua moglie se non ama i suoi genitori, compagni e amici. E quanto più ampio sarà l’ambito di questo amore non sessuale, tanto più nobile sarà l’amore sessuale”.
L'amore non è solo un sentimento individuale, ma anche una forma specifica di relazioni umane, che presuppone la massima intimità e vicinanza. L'età di transizione in questo senso è molto contraddittoria. Un sogno d'amore giovanile esprime, innanzitutto, il bisogno di contatto emotivo, di comprensione e di intimità spirituale; i motivi erotici in esso non sono quasi espressi o non realizzati. Il bisogno di rivelazione di sé e l'intima intimità umana e i desideri sensuali-erotici molto spesso non coincidono e possono essere diretti verso oggetti diversi. La disunione tra attrazione sensuale-erotica e “tenera” è particolarmente tipica dei ragazzi. Ciò è in parte dovuto al fatto che in molti di loro il ritmo rapido della pubertà supera lo sviluppo di capacità comunicative sottili, inclusa la capacità di empatia. C’è anche l’influenza del tradizionale stereotipo della “mascolinità”, secondo il quale un uomo si avvicina a una donna “da una posizione di forza”. Uno studente delle scuole superiori non sente questo potere in se stesso e i tentativi di simularlo per essere al livello di uno stereotipo non fanno altro che aumentare le sue difficoltà. La sete d’amore si unisce spesso alla paura di “perdersi”, di “sottomettersi”, ecc. Le ragazze a cui non è prescritta la “forza” sono esenti da questa preoccupazione, ma sono costrette a nascondere i propri hobby, tutelando la propria dignità e reputazione. Anche i sentimenti che provano non sono inequivocabili.
La risoluzione di queste contraddizioni intrapersonali dipende in gran parte da come si sviluppano le relazioni tra ragazzi e ragazze in un circolo più ampio. La separazione tra ragazzi e ragazze, in una forma o nell'altra, è un fenomeno universale nella storia della cultura. Nella società moderna, la segregazione (separazione) dei sessi è meno marcata e viene attuata spontaneamente, dai bambini stessi. Tuttavia esiste, creando una certa distanza psicologica tra ragazzi e ragazze, che non è così facile da superare. L'intimità psicologica è inizialmente più facile da raggiungere con una persona dello stesso sesso, con la quale l'adolescente è connesso da una vasta gamma di esperienze significative comuni, comprese quelle erotiche.
Il rapporto tra amicizia e amore è un problema complesso in gioventù. Da un lato, queste relazioni sembrano più o meno alternative. Secondo I.S. Kona e V.A. Losenkov, i giovani orientati verso un'ampia comunicazione di gruppo, di regola, non scelgono una ragazza come amica ideale e i giovani prevalgono nel primo cerchio della loro vera comunicazione. Al contrario, chi preferisce una ragazza come amica ideale solitamente ha meno amici dello stesso sesso, tende a considerare rara la “vera amicizia” ed è caratterizzato da una maggiore riflessività. L'apparizione di una ragazza amata riduce l'intensità emotiva dell'amicizia tra persone dello stesso sesso; un amico diventa più un buon compagno. D’altra parte, l’amore implica un grado maggiore di intimità rispetto all’amicizia; in un certo senso include l’amicizia. Se all'inizio dell'adolescenza il principale confidente è solitamente un amico dello stesso sesso, in seguito questo posto viene occupato da una persona cara. La combinazione della comunicazione spirituale con l'intimità fisica consente la massima rivelazione di sé di cui una persona è capace. Un giovane di 16-18 anni può ancora accontentarsi della compagnia di amici del suo stesso sesso. In età avanzata, la mancanza di contatto intimo con una ragazza non è più compensata dall'amicizia tra persone dello stesso sesso; Inoltre, sentendosi in ritardo rispetto ai suoi coetanei in questo senso, il giovane a volte diventa meno franco e si chiude in se stesso con gli amici.
Le relazioni tra ragazzi e ragazze li pongono di fronte a molti problemi morali, dal rituale del corteggiamento e delle dichiarazioni d'amore ai problemi di autodisciplina e responsabilità morale. Hanno un disperato bisogno dell’aiuto degli anziani, soprattutto dei genitori e degli insegnanti. Ma allo stesso tempo, i giovani vogliono e hanno tutto il diritto di proteggere il loro mondo intimo da intrusioni e sbirciamenti senza cerimonie.
La pubertà nei ragazzi avviene più tardi, ma è più rapida che nelle ragazze. I ragazzi sono caratterizzati da una fase della cosiddetta ipersessualità giovanile, che inizia nell'adolescenza e prosegue per 2-3 anni dopo la pubertà. Il periodo di ipersessualità è caratterizzato da una maggiore eccitabilità sessuale e da un aumento degli interessi e delle fantasie erotiche. La questione se esista una tale fase nelle ragazze è controversa. Sebbene maturino prima dei ragazzi, la loro attività orgasmica non aumenta bruscamente, come nei ragazzi, ma lentamente e gradualmente, raggiungendo il suo culmine molti anni dopo la maturazione. La sessualità delle donne è diversa da quella degli uomini anche psicologicamente. Secondo numerosi scienziati, il rapporto tra sensualità e tenerezza nelle donne è fondamentalmente diverso rispetto agli uomini. Una ragazza sviluppa prima il bisogno di intimità psicologica con un ragazzo e solo allora sviluppa sentimenti erotici. Pertanto, le ragazze, anche in età avanzata, chiamano più spesso amicizia la loro relazione con i ragazzi, perché sono più sensibili alle sottili sfumature psicologiche nelle relazioni.
Nella prima adolescenza, il problema centrale è solitamente la combinazione di “sesso”, cioè piacere fisico, sensuale, genitale e “amore”, cioè intimità umana totale, intimità psicologica, fusione delle anime. In un adolescente questi bisogni sono separati; in un adulto idealmente si fondono. Ma il grado e la durata di tale fusione dipendono da molte condizioni. La soppressione delle reazioni emotive, il nevroticismo, l'egocentrismo estremo, che rendono una persona incapace di intimità psicologica, minano anche le sue possibilità di amore di successo. Gravi difficoltà sono causate anche dall'adesione al rigido stereotipo di “mascolinità - femminilità”: un uomo che vede in una donna solo un oggetto sessuale (questo è spesso combinato con una bassa autostima) di solito non è capace di auto-rivelazione emotiva e contatto psicologico con lei. Per preparare i ragazzi e le ragazze alla vita familiare è necessario migliorare il sistema di educazione morale e di educazione sessuale.
Apparentemente, l'educazione sessuale dovrebbe essere condotta da una persona appositamente formata, un medico / insegnante / psicologo, il cui stesso ruolo conferisce alla conversazione caratteristiche di distacco e impersonalità: viene comunicato un certo sistema di conoscenza, ma come lo applichi a te stesso - nessuno ti interroga, se vuoi puoi chiedere. E, naturalmente, c'è bisogno (sia a casa che in biblioteca) di letteratura accessibile che uno studente delle scuole superiori possa leggere da solo.
Il compito non è “proteggere” i ragazzi e le ragazze dalla sessualità – cosa impossibile e non necessaria – ma insegnare loro come gestire questo importante aspetto della vita pubblica e personale, il che significa che gli studenti delle scuole superiori non devono solo conoscere la biologia del sesso , ma anche avere una chiara comprensione degli aspetti sociali e psicologici del problema.Quando ci si rivolge a ragazzi e ragazze sessualmente maturi, bisogna fare appello non agli argomenti dell'ingenuo egoismo biologico (attenzione, non nuocere alla salute), ma a un senso adulto di responsabilità sociale e morale, invitando a valutare attentamente la serietà dei loro sentimenti (“amo” o “mi piace”), la misura della loro maturità sociale, le difficoltà della maternità precoce, le difficoltà materiali e di altro tipo del matrimonio precoce , eccetera.
2. Formazione della personalità nella prima giovinezza
Lo sviluppo dell'autocoscienza nell'adolescenza e nella prima adolescenza è così brillante e chiaro che le sue caratteristiche e la valutazione del suo significato per la formazione della personalità durante questi periodi sono praticamente le stesse tra i ricercatori di diverse scuole e direzioni; gli autori sono abbastanza unanimi nel descrivendo come avviene il processo di sviluppo dell'autocoscienza durante questo periodo: a circa 11 anni, un adolescente sviluppa un interesse per il proprio mondo interiore, poi c'è una graduale complicazione e approfondimento della conoscenza di sé, allo stesso tempo c'è un aumento della sua differenziazione e generalità, che porta nella prima adolescenza (15-16 anni) alla formazione di un'idea relativamente stabile di sé, dei concetti di sé; All'età di 16-17 anni si verifica una speciale nuova formazione personale, che nella letteratura psicologica è designata con il termine "autodeterminazione". Dal punto di vista dell'autocoscienza del soggetto, è caratterizzata dalla consapevolezza di sé come membro della società e si concretizza in una posizione nuova, socialmente significativa.
Lo status sociale dei giovani è eterogeneo. L'attività e la struttura del ruolo dell'individuo in questa fase acquisiscono già una serie di nuove qualità adulte.
Il principale compito sociale di questa età è la scelta di una professione. La scelta della professione e della tipologia dell'istituto scolastico differenzia inevitabilmente i percorsi di vita delle ragazze e dei ragazzi, con tutte le conseguenze socio-psicologiche che ne conseguono.
La gamma dei ruoli socio-politici e degli interessi e delle responsabilità associati si sta espandendo.
Lo stato sociale intermittente e lo stato giovanile determinano anche alcune caratteristiche della loro psiche. I giovani sono ancora fortemente preoccupati per i problemi ereditati dall'adolescenza: la specificità della propria età, il diritto all'autonomia dagli anziani, ecc. Ma l’autodeterminazione sociale e personale presuppone non tanto l’autonomia dagli adulti, quanto un chiaro orientamento e determinazione del proprio posto nel mondo adulto.
Esistono due modi per autovalutarsi. Uno è misurare il livello delle tue aspirazioni con i risultati raggiunti. Il secondo modo di autostima è il confronto sociale, confrontando le opinioni degli altri su se stessi.
È noto che le immagini di sé sono complesse e ambigue. Ecco il vero “io” (come mi vedo in un momento reale), l’”io” dinamico (cosa sto cercando di diventare) e l’“io” ideale (cosa dovrei diventare, in base ai miei principi morali) ), e il fantastico “io”” (quello che vorrei essere se tutto fosse possibile), e tutta una serie di altri sé immaginabili. Anche l'autocoscienza di una persona matura non è esente da contraddizioni e non tutta l'autostima è adeguata.
L’adeguatezza dell’autostima aumenta con l’età. La discrepanza tra l'io reale e quello ideale è una conseguenza del tutto naturale della crescita dell'autocoscienza e un prerequisito necessario per un'autoeducazione mirata. Scoprire il tuo mondo interiore è un evento gioioso ed emozionante. Ma provoca anche molte esperienze inquietanti e drammatiche. L'io interiore non coincide con il comportamento “esterno”, attualizzando il problema dell'autocontrollo. "Nella mia mente, sono due esseri: l'"esterno" o qualcosa del genere e l'"interno"", scrive un bambino di seconda media. "L'"esterno" (si può chiamare, forse, un "guscio") è solitamente un manifestazione dell'interno: l'interno detta le sue decisioni, pensieri, argomenti. Ma a volte il “guscio” entra in un feroce combattimento con l’essere “interno”.
Insieme alla consapevolezza della propria unicità, unicità e differenza dagli altri arriva un sentimento di solitudine. L'io giovanile è ancora vago, vago e spesso viene vissuto come una vaga ansia o una sensazione di vuoto interiore che deve essere riempito con qualcosa. Aumenta quindi il bisogno di comunicazione e allo stesso tempo aumenta la sua selettività e il bisogno di privacy.
Prima dell’adolescenza, le differenze di un bambino rispetto agli altri attirano la sua attenzione solo in circostanze eccezionali e contrastanti. Il suo “io” si riduce praticamente alla somma delle sue identificazioni con varie persone significative. Per gli adolescenti e i giovani la situazione cambia. L'orientamento simultaneo verso diverse persone significative rende la sua situazione psicologica incerta e conflittuale internamente. “Gli altri significativi sono coloro che svolgono un ruolo importante nella vita di una persona. Sono influenti e le loro opinioni hanno molto peso. Il livello di influenza degli altri significativi su un individuo dipende dal grado del loro coinvolgimento nella sua vita, dalla vicinanza delle relazioni, dal sostegno sociale che forniscono e dal potere e dall’autorità di cui godono con gli altri”.
Il desiderio inconscio di sbarazzarsi delle precedenti identificazioni infantili attiva la sua riflessione, così come il sentimento della propria particolarità e differenza dagli altri. La consapevolezza delle proprie peculiarità e differenza rispetto agli altri provoca un sentimento di solitudine o paura della solitudine caratteristico della prima giovinezza.
Un tratto della personalità estremamente importante, in gran parte stabilito nella prima giovinezza, è l’autostima, vale a dire autostima generalizzata, il grado di accettazione o rifiuto di se stessi come individuo.
I concetti di sé di una persona nel processo della sua vita vanno in diverse direzioni. Innanzitutto vengono studiati i cambiamenti nel contenuto del concetto di sé e delle sue componenti. Successivamente, viene esaminato il grado della sua affidabilità e obiettività, vengono tracciati i cambiamenti nella struttura dell'immagine di sé. In tutti questi indicatori, l'età di transizione è notevolmente diversa sia dall'infanzia che dall'età adulta; a questo proposito esiste una linea tra un adolescente e un giovane.
Nella prima giovinezza si verifica un graduale cambiamento nelle componenti “oggettive” dei concetti di Sé, in particolare, il rapporto tra la componente fisica e quella morale-psicologica del proprio “io”. Il giovane si abitua al suo aspetto, forma un'immagine relativamente stabile del suo corpo, accetta il suo aspetto e di conseguenza stabilizza il livello delle aspirazioni ad esso associate. A poco a poco, ora vengono alla ribalta altre proprietà dell'io: capacità mentali, qualità volitive e morali, da cui dipende il successo delle attività e delle relazioni con gli altri. La complessità cognitiva e la differenziazione degli elementi dell'immagine di sé aumentano costantemente dalla giovane età all'età avanzata, senza interruzioni o crisi evidenti. Gli adulti distinguono in se stessi più qualità dei giovani, i giovani - più degli adolescenti, gli adolescenti - più dei bambini. La tendenza integrativa, da cui dipendono la coerenza interna e l'integrità dell'immagine di sé, si intensifica con l'età, ma un po' più tardi della capacità di astrarre. Le autodescrizioni degli adolescenti e dei giovani adulti sono meglio organizzate e strutturate rispetto a quelle dei bambini; sono raggruppate attorno a diverse qualità centrali. Tuttavia, l'incertezza del livello delle aspirazioni e le difficoltà di riorientamento dalla valutazione esterna all'autostima danno origine a una serie di contraddizioni sostanziali interne dell'autocoscienza, che servono come fonte di ulteriore sviluppo. Quando aggiungono la frase “Io sono nella mia mente...”, molti giovani sottolineano proprio la loro incoerenza: “nella mia mente sono un genio + una nullità”. I dati sulla stabilità dell'immagine di sé non sono del tutto chiari. Le autodescrizioni degli adulti dipendono meno da circostanze situazionali casuali. Tuttavia, nell’adolescenza e nella prima adolescenza, l’autostima a volte cambia in modo molto drammatico. Inoltre, il significato degli elementi di autodescrizione e, di conseguenza, la loro gerarchia può cambiare a seconda del contesto, dell'esperienza di vita dell'individuo o semplicemente sotto l'influenza del momento. Questo tipo di autodescrizione è un modo per caratterizzare l'unicità di ciascuna personalità attraverso la combinazione dei suoi tratti individuali. Per quanto riguarda il contrasto, il grado di chiarezza dell'immagine del Sé, anche qui avviene la crescita: dall'infanzia all'adolescenza e dalla giovinezza alla maturità, una persona è più chiaramente consapevole della sua individualità, delle sue differenze rispetto agli altri e attribuisce maggiore importanza a loro, in modo che l'immagine del Sé diventi uno degli atteggiamenti centrali della personalità, con cui mette in relazione il suo comportamento. Tuttavia, con un cambiamento nel contenuto dell'immagine di sé, il grado di significato delle sue singole componenti su cui la persona focalizza l'attenzione cambia in modo significativo. I cambiamenti legati all’età nella percezione umana includono un aumento del numero di categorie descrittive utilizzate, un aumento della flessibilità e della certezza nel loro utilizzo; aumentare il livello di selettività, coerenza, complessità e sistematicità di tali informazioni; l'uso di valutazioni e connessioni più sottili; maggiore capacità di analizzare e spiegare il comportamento umano; appare una preoccupazione per la presentazione accurata del materiale, il desiderio di renderlo convincente. Tendenze simili si osservano nello sviluppo delle caratteristiche del sé, che diventano più generalizzate, differenziate e correlate con un numero maggiore di “persone significative”. Le autodescrizioni nella prima adolescenza sono di natura molto più personale e psicologica rispetto all'età di 12-14 anni e allo stesso tempo enfatizzano più fortemente le differenze rispetto alle altre persone. L'idea di se stesso di un adolescente o di un giovane è sempre correlata all'immagine di gruppo del "noi" - un tipico coetaneo del suo genere, ma non coincide mai completamente con questo "noi". Gli studenti delle scuole superiori valutano le immagini del proprio “io” in modo molto più sottile e tenero rispetto al “noi” del gruppo. I giovani si considerano meno forti, meno socievoli e allegri, ma più gentili e capaci di comprendere un'altra persona rispetto ai loro coetanei. Le ragazze si attribuiscono meno socievolezza, ma maggiore sincerità, correttezza e lealtà. L’esagerazione della propria unicità, caratteristica di molti adolescenti, di solito scompare con l’età, ma non con un indebolimento del principio individuale. Al contrario, più una persona è anziana e sviluppata, maggiori sono le differenze che trova tra sé e il suo coetaneo “medio”. Da qui l'intenso bisogno di intimità psicologica, che sarebbe sia rivelazione di sé che penetrazione nel mondo interiore di un altro. La consapevolezza della propria diversità dagli altri precede logicamente e storicamente la comprensione della propria profonda connessione interiore e unità con le persone che ci circondano. I cambiamenti più evidenti nel contenuto delle autodescrizioni, nell'immagine di sé, vengono rilevati all'età di 15-16 anni. Questi cambiamenti vanno lungo le linee di una maggiore soggettività e descrizioni psicologiche. È noto che nella percezione di un'altra persona la psicologizzazione della descrizione aumenta notevolmente dopo 15 anni. Una persona descrive se stessa, sottolineando la variabilità, la flessibilità del suo comportamento, la sua dipendenza dalla situazione; nelle descrizioni dell'altro, al contrario, predominano indicazioni di caratteristiche personali stabili, che determinano stabilmente il suo comportamento nelle più diverse situazioni. In altre parole, un adulto tende a percepire se stesso, concentrandosi sulle caratteristiche soggettive di dinamismo, variabilità e altro, come un oggetto con proprietà relativamente immutabili. Questa percezione “dinamica” di sé nasce durante il passaggio alla prima adolescenza tra i 14 e i 16 anni. La formazione di un nuovo livello di autoconsapevolezza nella prima giovinezza segue le indicazioni individuate da L.S. Vygotskij, - integrare l'immagine di se stessi, “spostandola” “dall'esterno all'interno”. Durante questo periodo di età si passa da una certa visione “oggettivista” di se stessi “dall’esterno” a una posizione soggettiva e dinamica “dall’interno”. Durante il periodo di transizione dall'adolescenza alla prima adolescenza, nell'ambito della formazione di un nuovo livello di autocoscienza, si sviluppa anche un nuovo livello di atteggiamento verso se stessi. Uno dei punti centrali qui è il cambiamento nella base dei criteri per valutare se stessi, il proprio “io” - vengono sostituiti “dall'esterno verso l'interno”, acquisendo forme qualitativamente diverse, rispetto ai criteri per la valutazione di altre persone da parte di una persona. . Il passaggio dall'autostima privata a quella generale, olistica (cambio di basi) crea le condizioni per la formazione, nel vero senso della parola, del proprio atteggiamento verso se stessi, del tutto autonomo dagli atteggiamenti e dalle valutazioni degli altri, dall'autostima privata successi e fallimenti, tutti i tipi di influenze situazionali, ecc. È importante notare che la valutazione delle qualità individuali e degli aspetti della personalità gioca un ruolo subordinato in tale atteggiamento verso se stessi, e quello principale è una sorta di "accettazione di sé" generale e olistica, "rispetto di sé". È nella prima adolescenza (15-17 anni), sulla base dello sviluppo del proprio sistema di valori, che si forma un atteggiamento emotivo e valoriale verso se stessi, cioè L’“autostima operativa” inizia a basarsi sulla conformità del comportamento, delle proprie opinioni e convinzioni e dei risultati delle prestazioni. All'età di 15-16 anni, il problema della discrepanza tra il sé reale e il sé ideale diventa particolarmente acuto, secondo I.S. Kona, questa discrepanza è del tutto normale, una conseguenza naturale dello sviluppo cognitivo. Durante il passaggio dall’infanzia all’adolescenza e oltre, l’autocritica aumenta. Molto spesso, nella prima giovinezza, si lamentano di debolezza di volontà, instabilità, suscettibilità alle influenze, ecc., nonché di difetti come capricciosità, inaffidabilità, suscettibilità. La discrepanza tra il sé reale e il sé ideale è una funzione non solo dell'età, ma anche dell'intelligenza. Nei giovani intellettualmente sviluppati c'è una discrepanza tra il sé reale e il sé ideale, cioè. tra le proprietà che un individuo attribuisce a se stesso e quelle che vorrebbe possedere è significativamente maggiore di quella dei suoi coetanei con capacità intellettive medie. Da quanto precede consegue che è necessario individualizzare l'istruzione e la formazione, per rompere gli stereotipi e gli standard abituali rivolti agli individui medi, statisticamente medi! Il lavoro educativo di uno studente dovrebbe essere intenso, intenso e creativo. In questo caso, è necessario tenere conto non solo delle differenze individuali oggettive, ma anche del mondo soggettivo della personalità in via di sviluppo, dell'autostima e del concetto di sé. Facendo appello al potenziale creativo degli studenti, dobbiamo occuparci di aumentare la loro autostima e autostima, vedere le difficoltà psicologiche e le contraddizioni della crescita e aiutare con tatto a risolverle. Uno psicologo scolastico potrebbe essere di grande aiuto in questo caso. Nella giovinezza, tutte le forze dell'anima sono dirette verso il futuro, e questo futuro assume forme così diverse, vive e affascinanti sotto l'influenza della speranza, basata non sull'esperienza del passato, ma sulla possibilità immaginaria della felicità, che solo i sogni compresi e condivisi di felicità futura costituiscono la vera felicità di questa epoca. La scoperta del mondo interiore che avviene nella prima giovinezza è associata all'esperienza di esso come valore. La scoperta di se stessi come individuo unico è indissolubilmente legata alla scoperta del mondo sociale in cui questa persona vivrà. La riflessione giovanile è, da un lato, la consapevolezza del proprio “io” (“Chi sono io?”, “Che cosa sono?”, “Quali sono le mie capacità?”, “Perché posso rispettarmi?”), e dall'altro, la consapevolezza della propria posizione nel mondo (“Qual è il mio ideale di vita?”, “Chi sono i miei amici e nemici?”, “Chi voglio diventare?”, “Cosa devo fare per migliorare me stesso e il mondo intorno a me?”). Le prime domande rivolte a se stessi vengono poste, non sempre consapevolmente, da un adolescente. Le seconde domande, più generali, sulla visione del mondo sono poste dal giovane, per il quale l'autoanalisi diventa un elemento di autodeterminazione sociale e morale. La difficoltà sta nel fatto che la prima giovinezza, pur creando condizioni interne favorevoli perché una persona inizi a pensare al motivo per cui vive, non fornisce i mezzi sufficienti per risolverlo. È noto che il problema del senso della vita non è solo ideologico, ma anche pratico. La risposta è contenuta sia all'interno di una persona che all'esterno di essa - nel mondo in cui si rivelano le sue capacità, nelle sue attività, nel suo senso di responsabilità sociale. Ma è proprio questo che crea quel deficit, che a volte viene avvertito in modo molto doloroso nei giovani. Così, chiudendosi in se stessi, la ricerca del senso della vita è, per così dire, destinata a rimanere solo un esercizio di pensiero giovanile, che crea un reale pericolo di persistente egocentrismo e di ripiegamento su se stessi, soprattutto tra i giovani con tratti di nevroticismo o predisposto ad esso a causa delle caratteristiche dello sviluppo precedente (bassa autostima, scarsi contatti umani. Tuttavia, nonostante tutte le difficoltà soggettive, queste ricerche contengono un elevato potenziale positivo: nella ricerca del significato della vita si sviluppa una visione del mondo, si espande il sistema di valori, si forma un nucleo morale che aiuta ad affrontare i primi problemi quotidiani, il giovane inizia a comprendere meglio il mondo che lo circonda e se stesso, diventa in realtà se stesso .
L'autodeterminazione sociale e la ricerca di se stessi sono indissolubilmente legate alla formazione di una visione del mondo. La giovinezza è una fase decisiva nella formazione di una visione del mondo, perché è in questo momento che maturano sia i suoi prerequisiti cognitivi che quelli emotivi e personali. L'adolescenza è caratterizzata non solo da un aumento del volume delle conoscenze, ma anche da un'enorme espansione degli orizzonti mentali di uno studente delle scuole superiori, dall'emergere di interessi teorici e dalla necessità di ridurre la varietà dei fatti a pochi principi. Sebbene il livello specifico di conoscenza, abilità teoriche e ampiezza di interessi tra i ragazzi siano molto diversi, tra tutti si osservano alcuni cambiamenti in questa direzione, dando un potente impulso al “filosofare” giovanile. La visione del mondo è una visione del mondo nel suo insieme, un sistema di idee sui principi generali e sui fondamenti dell'esistenza, la filosofia di vita di una persona, la somma e il risultato di tutta la sua conoscenza. I prerequisiti cognitivi (cognitivi) per una visione del mondo sono l'assimilazione di una certa e molto significativa quantità di conoscenza (non può esserci una visione del mondo scientifica senza padronanza della scienza) e la capacità dell'individuo di pensare teorico astratto, senza il quale le disparate conoscenze specializzate non formano un sistema unico. Ma una visione del mondo non è tanto un sistema logico di conoscenza quanto un sistema di credenze che esprimono l'atteggiamento di una persona nei confronti del mondo, i suoi principali orientamenti di valore. Per comprendere il problema dell'autodeterminazione personale, va notato un punto estremamente significativo: il livello della personalità è il livello di determinazione semantica del valore, il livello di esistenza nel mondo dei significati e dei valori. Come sottolinea B.V. Zeigarnik e B.S. Bratus, per l’individuo, “il piano principale del movimento è morale e basato sui valori. Il primo punto è che l'esistenza dei significati nel mondo è un'esistenza a livello effettivamente personale (lo ha sottolineato L.S. Vygotskij); l'area dei significati e dei valori è l'area in cui avviene l'interazione tra l'individuo e la società; valori e significati sono, in senso stretto, il linguaggio di questa interazione. Il secondo punto è il ruolo guida dei valori per la formazione della personalità: la confessione dei valori consolida l'unità e l'identità personale dell'individuo, determinando a lungo le principali caratteristiche della personalità, il suo nucleo, la sua moralità , la sua etica. Il valore è acquisito dall'individuo, poiché “...non c'è altro modo di affrontare il valore se non la sua esperienza olistica e personale. Pertanto, l'acquisizione di valore è l'acquisizione di se stessa da parte di una persona. E il terzo - assegnato B.V. Zeigarnik e B.S. Funzioni di Bratusem dell'educazione semantica: creare uno standard, un'immagine del futuro e valutare l'attività dal suo lato morale e semantico. Gli orientamenti valoriali sono elementi della struttura della personalità che caratterizzano il lato contenutistico del suo orientamento. Sotto forma di orientamenti di valore, come risultato dell'acquisizione di valori, viene registrato l'essenziale, il più importante per una persona. Gli orientamenti di valore sono formazioni stabili e invarianti ("unità") di coscienza morale: le sue idee di base, concetti, "blocchi di valore", componenti semantici di una visione del mondo che esprimono l'essenza della moralità umana, e quindi condizioni e prospettive culturali e storiche generali. Il loro contenuto è mutevole e mobile. Il sistema di orientamenti di valore agisce come un programma "collassato" di attività di vita e serve come base per l'implementazione di un determinato modello di personalità. La sfera in cui il sociale si trasforma in personale e il personale diventa sociale, dove si scambiano valori individuali e differenze di visione del mondo è la comunicazione. Il valore è uno dei principali meccanismi di interazione tra individuo e società, individuo e cultura. Il valore è uno dei principali meccanismi di interazione tra individuo e società, individuo e cultura. I valori sono idee generalizzate delle persone sugli obiettivi e sulle norme del loro comportamento, che incarnano l'esperienza storica ed esprimono concentratamente il significato della cultura di un'epoca, di una certa società nel suo insieme e di tutta l'umanità. Si tratta di linee guida esistenti nella coscienza di ogni persona con le quali individui e gruppi sociali correlano le proprie azioni. Pertanto, i valori e la coscienza del valore sono alla base della definizione degli obiettivi. Gli obiettivi possono influenzare l’attività umana non in modo causale reale, ma come valori ideali, la cui attuazione una persona considera il suo bisogno o dovere urgente”. Uno studente senior è sul punto di entrare in una vita lavorativa indipendente. Si trova di fronte a compiti fondamentali di autodeterminazione sociale e personale. Un giovane e una ragazza dovrebbero preoccuparsi di molte domande serie: come trovare il proprio posto nella vita, scegliere un'attività in base alle proprie capacità e capacità, qual è il significato della vita, come diventare una persona reale e molti altri . Gli psicologi che studiano le questioni della formazione della personalità in questa fase dell'ontogenesi associano il passaggio dall'adolescenza all'adolescenza con un brusco cambiamento nella posizione interna, che consiste nel fatto che l'aspirazione al futuro diventa l'orientamento principale dell'individuo e il problema della scelta una professione, un ulteriore percorso di vita è al centro dell'attenzione degli interessi, dei piani degli studenti delle scuole superiori. Un giovane (ragazza) si sforza di assumere la posizione interna di un adulto, di riconoscersi come membro della società, di definirsi nel mondo, ad es. comprendere te stesso e le tue capacità oltre a comprendere il tuo posto e il tuo scopo nella vita. Il compito principale formulato è pienamente coerente con il fatto che l’attività principale della gioventù è considerata la ricerca del proprio posto nella vita. Nella ricerca del significato della propria esistenza, la natura valore-semantica dell’autodeterminazione personale si manifesta nella forma più generale. Il bisogno di senso della vita caratterizza i comportamenti adulti e pertanto non può essere ignorato quando si tratta del processo di maturazione dell'individuo, della formazione dell'io umano. Viktor Frankl considera il desiderio di una persona di cercare e realizzare il significato della propria vita come una tendenza motivazionale innata inerente a tutte le persone ed è il principale motore del comportamento e dello sviluppo di un adulto. L'autodeterminazione personale non termina affatto nell'adolescenza e nella prima adolescenza, e nel corso dell'ulteriore sviluppo una persona arriva a una nuova autodeterminazione personale (ridefinizione). L’autodeterminazione personale è la base del proprio sviluppo. Questa comprensione ci consente di costruire un quadro olistico dell'autodeterminazione nell'adolescenza, all'interno del quale assume significato il mosaico eterogeneo di varie “autodeterminazioni” presenti in letteratura. L'autodeterminazione personale stabilisce un orientamento personalmente significativo verso il raggiungimento di un certo livello nel sistema delle relazioni sociali, i requisiti per esso, ad es. stabilisce l’autodeterminazione sociale. Sulla base dell'autodeterminazione sociale, vengono sviluppati i requisiti per un determinato campo professionale e viene effettuata l'autodeterminazione professionale. Nella psicologia dello sviluppo, l'autodeterminazione professionale è solitamente suddivisa in una serie di fasi, la cui durata varia a seconda delle condizioni sociali e delle caratteristiche di sviluppo individuali. La prima fase è il gioco infantile, durante il quale il bambino assume diversi ruoli professionali e “mette in scena” singoli elementi del comportamento ad essi associati. La seconda fase è la fantasia adolescenziale, quando un adolescente si vede nei suoi sogni come un rappresentante dell'una o dell'altra professione che lo attrae. La terza fase, che copre tutta l'adolescenza e gran parte dell'adolescenza, è la scelta preliminare di una professione. Varie attività vengono ordinate e valutate in base agli interessi dell'adolescente ("Amo i romanzi storici, diventerò uno storico"), quindi in base alle sue capacità ("Sono bravo in matematica, dovrei iniziare?" ), e infine , dal punto di vista del suo sistema di valori (“Voglio aiutare i malati, diventerò medico”; “Voglio guadagnare molto. Quale professione soddisfa questo requisito?”). Naturalmente interessi, capacità e valori compaiono, almeno implicitamente, in ogni fase della scelta. Ma gli aspetti valoriali, sia pubblici (consapevolezza del valore sociale di una determinata professione) che personali (consapevolezza di ciò che l'individuo vuole per sé), sono più generalizzati e solitamente maturi e vengono riconosciuti più tardi degli interessi e delle capacità, della differenziazione e del consolidamento delle che avviene in parallelo e interconnesso. L'interesse per la materia stimola lo studente a studiarla di più, questo sviluppa le sue capacità; e le abilità identificate, aumentando il successo dell'attività, a loro volta rafforzano l'interesse. La quarta fase è il processo decisionale pratico, vale a dire La scelta effettiva della professione comprende due componenti principali: 1) determinazione del livello di qualificazione del lavoro futuro, volume e durata della preparazione per esso, 2) scelta di una specialità. Una caratteristica della prima giovinezza è la formazione di progetti di vita. Conclusione
Sono stati quindi considerati i principali approcci teorici allo studio della psicologia giovanile. Nelle loro forme estreme sembrano escludersi a vicenda e si sono sviluppati in accesi dibattiti tra loro. Tuttavia, nonostante tutte le differenze nei principi iniziali, queste teorie spesso descrivono gli stessi processi e li periodizzano più o meno nello stesso modo. La tensione psicologica è una conseguenza della pubertà, dell'incertezza dello status sociale o degli orientamenti di valore contraddittori di un adolescente? Questa domanda non può essere posta secondo il principio “o-o”, poiché tutti questi punti sono presenti e il problema sta proprio nella loro interazione. Teorie diverse affrontano il problema semplicemente da angolazioni diverse e in questo senso sono complementari. È impossibile negare il significato delle teorie avanzate da questi autori, né la legittimità dello studio specifico dei processi psicofisiologici, dello sviluppo psicosessuale, delle emozioni, dell'intelligenza, dell'autocoscienza, ecc. Ma questi processi particolari stessi possono essere compresi solo nella loro interconnessione e interdipendenza, basata sul principio dell'unità di coscienza e attività. Prima di tutto, opera la legge della maturazione e dello sviluppo disomogeneo. Questa disuguaglianza è sia interpersonale (gli adolescenti maturano e si sviluppano a ritmi diversi, quindi i coetanei e i compagni di classe possono effettivamente trovarsi a stadi diversi del loro sviluppo individuale) che intrapersonale (eterocronicità nello sviluppo fisico, sessuale, mentale, sociale e morale dello stesso individuo ). Pertanto, la prima domanda che sorge quando si incontra uno studente delle scuole superiori è: con chi abbiamo effettivamente a che fare: un adolescente, un giovane o un adulto, e non in generale, ma in relazione a questo specifico ambito della vita? Inoltre, a seconda delle caratteristiche tipologiche individuali, esistono tipi di sviluppo fondamentalmente diversi. Per alcune persone, l'adolescenza è un periodo di “tempesta e stress”, che procede in modo turbolento e di crisi, caratterizzato da gravi difficoltà emotive e comportamentali, conflitti acuti con gli altri e con se stessi. Per altri la giovinezza procede dolcemente e gradualmente, entrano nella vita adulta con relativa facilità, ma in una certa misura passivamente; gli impulsi romantici, solitamente associati alla giovinezza, sono insoliti per loro; Queste persone causano i minimi problemi agli educatori, ma nel loro sviluppo i meccanismi di coping possono bloccare la formazione dell'indipendenza. Il terzo tipo di gioventù è caratterizzato da cambiamenti rapidi e repentini, che però sono efficacemente controllati dall'individuo stesso, senza provocare crolli emotivi improvvisi; Avendo determinato presto i loro obiettivi di vita, questi ragazzi e ragazze si distinguono per un alto livello di autocontrollo, autodisciplina e bisogno di risultati, formano attivamente la propria personalità, ma la loro introspezione e la vita emotiva sono meno sviluppate. È importante tenere presente che nella maggior parte dei casi non stiamo parlando solo di età, ma di genere e caratteristiche dell'età. La psicologia delle differenze sessuali è metodologicamente molto complessa; la sua seria ricerca scientifica è iniziata solo negli ultimi decenni. Nella psicologia russa è stato per molti anni sottovalutato35. Tuttavia, le stesse differenze di genere sono molto significative, manifestandosi nella direzione degli interessi, nella specificità delle reazioni emotive, nella struttura della comunicazione, nei criteri di autostima, nello sviluppo psicosessuale e persino nella il rapporto tra le fasi e le caratteristiche di età della vita professionale, lavorativa e coniugale, l'autodeterminazione sessuale. Le caratteristiche e i processi di sesso ed età sono sempre strettamente intrecciati con quelli personali. Per l'adolescenza sono particolarmente importanti i processi di sviluppo dell'autocoscienza e le dinamiche di autoregolamentazione dell'immagine di sé. Elenco delle fonti utilizzate
1Aismontas B.B. Psicologia generale: schemi: M.: VLADOS-PRESS. -2008. Gorokhova L.G. Studio delle strategie di coping negli adolescenti // Annuario della Società psicologica russa: materiali del 3o Congresso panrusso degli psicologi. 25-28 luglio 2003: T.2 - San Pietroburgo, 2008. Zimnyaya I.A. Psicologia dell'educazione: Proc. Per studenti Università. - 2a ed., - M.: Logos. - 2007. Kolienko N.S., Rubtsova N.E. Raccomandazioni metodologiche per lo sviluppo del pensiero creativo. - Tver: TvGU, 2007. Maksimova S.V. Attività creativa nelle persone con tossicodipendenza // Domande di psicologia. - M., 2006. - N. 1. Malkina-Pykh I.G. Crisi dell'adolescenza. - M.: Casa editrice Eksmo, 2009. Mukhina V.S. "Età. Psicologia: fenomenologia dello sviluppo, dell'infanzia, dell'adolescenza: libro di testo per gli studenti. Università. - 3a ed., stereotipo. - M.: Accademia. -2008. Nemov R.S. Psicologia: libro di testo. per studenti più alto ped. manuale stabilimenti. M.: Umanitario. ed. Centro VLADOS, 2007. Romanova N.M. Test "Disegno di un uomo e una donna" // Journal of Applied Psychology. - 2008. - N. 3. Kjell L, Ziegler D. Teorie della personalità, principi di base, ricerca e applicazioni - Ed. Pietro, San Pietroburgo, 2006.
La gioventù è una fase decisiva nella formazione di una visione del mondo. Una visione del mondo non è solo un sistema di conoscenza ed esperienza, ma anche un sistema di credenze, la cui esperienza è accompagnata da un sentimento della loro verità e correttezza. I fenomeni della realtà interessano il giovane non in sé, ma in relazione al proprio atteggiamento nei loro confronti. Durante questo periodo della vita, una persona ha la necessità di ridurre tutta la varietà dei fatti a pochi principi: la formazione della propria posizione ideologica include l'orientamento sociale dell'individuo, la consapevolezza di se stessi come parte di una comunità sociale (sociale gruppo, nazione, ecc.. La via d'uscita da questa situazione è quella di includere, accanto alle materie tradizionali dell'istruzione generale, corsi di economia, politica, diritto e vari tipi di arte come obbligatori nel curriculum scolastico. complicato con la parte scientifica e religiosa della visione del mondo. Il problema che deve essere risolto ora non è continuare a contrapporre scienza e religione, ma innalzare il livello di cultura e di istruzione delle persone in entrambi gli ambiti, dando a ogni giovane persona una reale opportunità di scegliere individualmente in cosa credere: scienza o religione
35. Approcci alla classificazione per età
nell'acmeologia
Le difficoltà di periodizzazione in età adulta sono associate alla mancanza di dati sistematici sui cambiamenti nei processi psicologici e sulle caratteristiche personali durante i diversi periodi dell'età adulta.
La necessità di sviluppare la psicologia dello sviluppo degli adulti è stata causata dalle esigenze della pratica della formazione e dell'educazione degli adulti, dell'organizzazione del loro lavoro e del tempo libero nei diversi periodi della vita. Nelle periodizzazioni di età che esistono oggi (D. Birren, D. Bromley, D. Wexler, V. V. Bunak, V. V. Ginzburg), i limiti inferiore e superiore della maturità non coincidono, e non c'è nemmeno consenso sui confini della giovinezza . L'incoerenza nel determinare i limiti di età è spiegata da diversi principi per la costruzione delle classificazioni dei periodi di età: fisiologico, antropologico, demografico, psicologico. In accordo con i dati sperimentali dello studio, il processo di sviluppo psicofisiologico degli adulti è eterogeneo. All'età di 18-46 anni si distinguono tre macroperiodi nello sviluppo della memoria, del pensiero e dell'attenzione.
Lo studio delle connessioni interfunzionali tra i processi mentali di un adulto ha dimostrato che nel processo di ristrutturazione e trasformazione delle strutture interfunzionali, elementi di una nuova struttura nascono nel profondo di quella vecchia. Le trasformazioni strutturali del sistema intellettuale avvengono sotto l'influenza di fattori di vita, che sono la causa di cambiamenti qualitativi nell'intelligenza come sistema integrale. Tra questi fattori, il ruolo decisivo nello sviluppo ontogenetico umano spetta all'attività educativa e lavorativa.
36. Crisi dell'età adulta.
Le crisi della maturità sono chiaramente individuate: la crisi dei trent'anni, la crisi della mezza età (40-45 anni), la crisi dell'età avanzata (55-60 anni). Vygotsky, crisi o periodo critico, è un momento di cambiamenti qualitativi positivi, il cui risultato è la transizione dell'individuo a uno stadio di sviluppo nuovo e più elevato. Le crisi degli adulti, rispetto a quelle dei bambini, non sono così strettamente legate all'età. Spesso maturano gradualmente, ma possono anche insorgere all’improvviso, in caso di cambiamenti improvvisi nella situazione sociale di una persona. Per crisi di transizione alla vecchiaia intendiamo il periodo corrispondente al momento del pensionamento di una persona. carattere esistenziale , poiché la loro esperienza comprende problemi sul senso della vita e sull'esistenza individuale. crisi spirituali , la cui caratteristica comune è il richiamo a valori più elevati. Crisi personale negli adulti può insorgere a causa dell'esperienza di una o di un'altra situazione difficile. Crisi familiare associato alla transizione della famiglia verso una nuova fase del ciclo di vita. Succede e crisi professionali causati da crescita professionale o cambiamenti nel campo di attività.
|
37. La psicologia umana nella prima età adulta (gioventù) |
|
I limiti di età vanno dai 21 ai 30 anni. L'attività principale nei giovani è l'attività professionale. Nuove formazioni psicologiche dell'età: maturità sociale, soggettività, bisogno di genitorialità. Caratteristiche dello sviluppo della sfera cognitiva: c'è un elevato volume di memoria verbale, la memorizzazione è caratterizzata da un pensiero creativo a lungo termine è molto utilizzato per risolvere situazioni di vita. Caratteristiche dello sviluppo della sfera sociale: si acquisisce la maturità sociale. L'attività umana è finalizzata a padroneggiare l'attività professionale, acquisire una certa posizione in essa, creare e mantenere la propria famiglia, apprendere e accettare i ruoli di genitore, coniuge, partner sessuale, nonché padroneggiare e applicare le norme della vita sociale (cittadino stato). Crisi giovanile. Si verifica all'età di 30 anni e termina il periodo di sviluppo mentale di una persona in gioventù. Questa crisi è anche chiamata “crisi d’identità”. La sua base è legata alle contraddizioni tra lo stile di vita desiderato e le condizioni di vita familiare, professionale e sociale effettivamente raggiunte. Quest'ultimo, molto spesso, non soddisfa una persona. 44. Caratteristiche socio-psicologiche di una personalità adulta. Anche gli adulti cercano di raggiungere una certa stabilità non solo nel lavoro, ma anche in altri ambiti della loro vita. La posizione rispetto alle altre persone cambia. Un adulto non solo è pienamente responsabile di se stesso, ma inizia anche a rendersi conto della responsabilità verso le altre persone, verso i giovani che non hanno ancora esperienza di vita, verso i loro figli. Una tendenza peculiare a costruire e vivere la vita esattamente in questo modo e trovare in questo l'esperienza della verità, del valore, del significato del proprio percorso di vita e della soddisfazione dalla vita. Si formano qualità personali come obiettività, equilibrio ed efficienza. All'età di 40 anni, una persona acquisisce una pienezza unica dell'esistenza originaria, che consiste nella diversità dei suoi diritti e responsabilità nei diversi ambiti della vita e dell'attività: nella società, nel lavoro e nella famiglia. 38.SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ NEI GIOVANI. CRISI GIOVANILE(prima età adulta - gioventù, 21-30 anni) Caratteristiche dello sviluppo della sfera personale: appare la soggettività, il fenomeno della "conservazione dell'età", motivazioni e bisogni diventano dipendenti dagli standard sociali, l'identità viene raggiunta e la sua implementazione nel sistema delle relazioni sociali, alta regolazione volitiva, l'autostima si espande e diventa differenziato. L'età adulta differisce dalla giovinezza nell'emergere di nuove opportunità, nel prendere autonomamente decisioni importanti, nel fissare obiettivi per se stessi e nella scelta dei modi per raggiungerli. L'adulto diventa libero e indipendente nella sua scelta, ma pienamente responsabile della stessa e dei risultati ottenuti. Ciò che conta è la stabilità dei processi mentali. Lo sviluppo personale ti consente di gestire i tuoi desideri e aspirazioni. Una crisi di sviluppo può manifestarsi in diversi modi. Vediamo le sue forme: 1) identità incerta: un giovane è spaventato da una nuova situazione, non vuole cambiare nulla e, di conseguenza, crescere. Non ha progetti di vita, aspirazioni, affari che vorrebbe fare (non può decidere sulla sua futura professione); 2) identificazione a lungo termine: una persona ha deciso da tempo la sua scelta professionale, ma non si basava sui propri desideri e aspirazioni, ma sulle opinioni degli altri; 3) la fase della moratoria: una persona deve affrontare una scelta difficile, quando gli si aprono molte porte, molte opportunità e deve scegliere una cosa per se stesso |